di Alessandro Coscia
Gli autori greci e romani ci hanno lasciato racconti di visioni, viaggi, incontri in dimensioni sconosciute, avvenuti sulla soglia della morte. Alcune di queste narrazioni assomigliano straordinariamente ai moderni resoconti di esperienze post mortem. Cosa si nasconde dietro questa tradizione?
* * *
Nel dialogo platonico Fedone, Socrate racconta a Simmia, il filosofo pitagoreo discepolo di Filolao, “come si trovino d’essere le cose sopra la terra, al di sotto del cielo”. Comincia così la descrizione della sfera terrestre, come appare a chi contempli dallo spazio la “vera terra”; in altri termini, la superficie del globo avvolta dall’etere e invisibile per gli umani che risiedono nell’oikuméne, sul suolo dove abitano i mortali “intorno al mare (Mediterraneo), come, intorno a uno stagno, delle formiche o dei ranocchi”.
La vera terra, “per chi guardi dall’alto”, somiglia a una palla di cuoio, di quelle a dodici spicchi, distinta a colori, di cui anche i colori di quaggiù, quelli usati dai pittori, sono pallide imitazioni. Lassù invece, “a quanto dicono”, tutta la terra è colorata di colori brillanti e puri. In alcuni punti appare purpurea, in altri ha il fulgore dell’oro, e dove è bianca, è più bianca del gesso e della neve. Le parole immaginifiche di Socrate esaltano la policromia e la straordinaria visione negata agli umani.
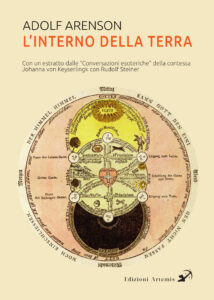
Il grande filologo Giovanni Pugliese Carratelli, in alcune delle sue pagine più belle, ha paragonato questa immagine alle descrizioni del nostro pianeta fatte dai primi cosmonauti o documentate dalle foto dei satelliti.
Questa visione è, dagli antichi, associata ad un’esperienza paradigmatica, liminare: il viaggio nell’Ade. Proclo, nel suo commento alla Repubblica di Platone, cita “numerosi autori antichi” e in particolare lo scritto di Democrito Sull’Ade: in questi testi si troverebbero notizie di persone “che erano state credute morte e poi erano tornate in vita”. In questo contesto, Proclo menziona un passaggio del Peri upnou (Sul sogno) di Clearco di Soloi, un discepolo di Aristotele. Clearco narra di un Cleonimo Ateniese, amante della filosofia, che, preso da così profondo dolore per la morte di un suo amico, perse totalmente i sensi e, ritenuto morto, venne esposto per tre giorni (come prescrivevano le norme funebri). La madre, venuta a dargli un ultimo bacio, avvertì un lieve soffio nella sua bocca, e bloccò subito le procedure di tumulazione. Dopo avere gradualmente ripreso i sensi, Cleonimo narrò quanto aveva visto e udito dal momento in cui “si era distaccato dal corpo”. A Cleonimo era parso
“che la sua anima nel momento della morte abbandonasse il corpo come liberata da vincoli; e così s’era sollevata in aria, e alta sulla terra aveva in questa veduto luoghi assai vari per forme e colori, e corsi di fiumi non visibili agli uomini…”.
L’esperienza di questa visione è quindi legata ad episodi di catalessi e di ekstasis, di distacco dell’anima dal corpo, in seguito a casi di morte apparente. Varie tradizioni greche narrano di episodi di catalessi procurata o involontaria; ma, come ha notato già Pugliese Carratelli, tra i diversi racconti relativi alle anime staccate dal corpo non si incontrano altri esempi di visione della sfera terrestre dall’alto dello spazio.
Le visioni del catalettico Er nella Repubblica di Platone, o quelle di Tespesio di Soloi nell’opera di Plutarco De sera numinis vindicta (Sulla tempestività della punizione divina), tanto per citare alcuni esempi, riguardano l’oltretomba e i viaggi nel regno dei morti con le relative pene.
L’unica esperienza accostabile a quella narrata nel Fedone è in un’altra opera di Plutarco, Sul demone di Socrate, in cui si narra di Timarco di Cheronea, che, recatosi a consultare il famoso oracolo di Trofonio:
“levando lo sguardo in alto non vide affatto terra, ma isole risplendenti di mite fuoco, che si scambiavano l’una con l’altra, come una tintura, il colore di volta in volta diverso, mentre la luce variava in armonia con le mutazioni di colore, (…) e in mezzo ad esse si stendeva un mare o un lago risplendente di colori commisti sul fondo azzurro”.
La consultazione dell’oracolo di Lebadea (situato non lontano da Cheronea, sulla strada di Delfi), consacrato al mitico personaggio di Trofonio, consisteva in una catabasi rituale che comportava un’incubazione: ce ne parla, oltre a Plutarco, Pausania, che fornisce un certo numero di particolari sulle pratiche divinatorie. Chi voleva consultare l’oracolo, scrive Pausania, doveva sottostare a una purificazione che comportava l’astensione per vari giorni dalle “cose illecite” (probabilmente si trattava di tabù alimentari, come ipotizza lo storico delle religioni Ioan Coulianu sulla scorta di un passo del poeta comico Cratino). Dopo un bagno rituale, e dopo l’esame delle viscere di un montone nero sacrificato di notte in una fossa, il postulante veniva nuovamente lavato nell’acqua del fiume Hercyna, sacro ad Asclepio–Trofonio e ad Igea-Hercyna, rispettivamente divinità tutelari della medicina e della salute. Due bambini chiamati Hermai ungevano d’olio il suo corpo. Il sacerdote lo conduceva poi presso le due sorgenti chiamate Lete e Mnemosyne. Bevendo alla fonte Lete, il consultante dimenticava tutto il suo passato, mentre l’acqua di Mnemosyne gli consentiva di ricordare l’esito dell’oracolo. Quindi, vestito di una tunica di lino bianco, il postulante iniziava la vera e propria catabasi: condotto davanti a una grotta, grazie a una scala portatile scendeva per un percorso che lo portava all’imboccatura di un orifizio stretto, dove doveva penetrare, coi piedi in avanti, tenendo in mano alcune focacce fatte col miele. Infine, un soffio potente lo aspirava nell’adyton, fino al fondo.
La permanenza nell’antro durava a lungo e la rivelazione poteva avvenire sia attraverso una visione, sia mediante una “voce” (Pausania, Descrizione della Grecia, IX, 39, 12).
Al termine della consultazione, si emergeva dall’antro nello stesso modo in cui si era entrati, cioè coi piedi in avanti.
Tutto il sistema di simboli e di rituali connessi a questo oracolo ruotano intorno a un paradigma di morte/iniziazione: l’unzione del consultante, pratica che veniva adottata per i defunti, le focacce funebri fatte col miele (altro elemento legato al concetto di immortalizzazione), la presenza delle fonti d’acqua “escatologiche”, la “resurrezione” finale. Tutto lo scenario ha un sapore arcaico e mostra analogie con riti sciamanici di altre civiltà, senza per questo volerne dedurre una filiazione o un legame più o meno diretto: la grotta e i riti di penetrazione in una cavità sotterranea hanno sempre un fine estatico e sono caratteristiche delle iniziazioni sciamaniche. Questo vale anche per il contenuto della visione di Timarco, quando, appena disceso nell’oscurità dell’antro, “gli sembrò… di avere ricevuto un colpo sulla testa, accompagnato da un rumore assordante, e che le suture del suo cranio si fossero disgiunte per lasciare libero passaggio all’anima” (Plutarco, Sul demone di Socrate, 590b). Il ritorno dell’anima nel corpo avviene allo stesso modo:
“Sentì di nuovo un violento dolore alla testa, come se questa avesse subito una forte pressione”.
Jean Hani e Joan Coulianu hanno evidenziato
“la somiglianza fra il disgiungersi delle suture craniche in Timarco e il raggiungimento della libera circolazione dell’anima fuori dal corpo attraverso la sutura frontalis presso le popolazioni indo-tibetane”.
Il brahmārandhra o “becco di Brahma” è in effetti l’apertura del cranio che permette, secondo queste tradizioni, l’uscita dell’anima. Varie testimonianze di riti sciamanici confermano tale simbologia della testa: oltre alla fuoriuscita dell’anima dal cranio (presso i Nuba dell’Africa lo sciamano iniziando racconta di avere l’impressione che “lo spirito lo abbia abbandonato uscendo dalla testa”), abbiamo casi in cui l’anima di un malato viene reinserita nel corpo attraverso il cranio durante operazioni taumaturgiche; è il caso degli sciamani del Dayak (Borneo), che catturano l’anima dei malati durante una discesa agli inferi e la ricollocano nel corpo tramite il capo. E ancora, l’anima di uno sciamano penetra nel corpo della futura madre attraverso la testa.

Timarco dunque ascolta l’armonia delle sfere e contempla gli astri sotto forma di isole che volteggiano nell’etere. In mezzo alle isole si trova un lago, che corrisponde probabilmente alla sfera celeste. Una corrente più rapida rappresenta l’equatore celeste, mentre lo zodiaco è situato sulla cintura dei tropici. Plutarco, in sintesi, utilizzando metafore poetiche, introduce nella visione di Timarco nozioni astronomiche (tra cui anche quella dell’inclinazione dell’ellittica). Plutarco ha sicuramente adottato il modello del Fedone platonico, trasferendo però nel cielo il paesaggio escatologico di Platone, come ad esempio i due fiumi di fuoco che si gettano nel mare, probabile allusione al passo in Fedone 111, ma che qui corrispondono alle due braccia della Via Lattea. Guardando verso il basso, Timarco vede
“un vasto abisso arrotondato, simile a una sfera tagliata, orribilmente spaventoso e profondo, pieno di dense tenebre, non ferme, ma spesso agitate come delle onde”.
Da queste tenebre provengono gemiti di animali, pianti di uomini e di donne, accompagnati da un rumore confuso. Lo scrittore e sacerdote greco usa il termine ektaratomenou per indicare l’agitarsi delle tenebre: il riferimento voluto, e potente dal punto di vista icastico, è quello al Tartaro, luogo di punizioni oltremondane. Non possiamo qui entrare nel dettaglio delle interpretazioni sulla collocazione del Tartaro nell’escatologia greca. Ma ciò che Timarco vede, molto probabilmente, è la nostra terra; nel passo di un altro dialogo plutarcheo si dice che
“un abitante della Luna che contemplasse dall’alto la terra avrebbe l’impressione di scorgervi l’Ade e il Tartaro”.
Ma torniamo alla domanda fondamentale: all’origine di queste rielaborazioni letterarie, può esserci stata l’esperienza di fenomeni di reale ektasis, in punto di morte, fosse essa apparente o rituale?
Pugliese Carratelli per primo ha colto la stupefacente analogia tra il passo di Platone da cui siamo partiti e una testimonianza del noto psicologo, medico e intellettuale Carl Gustav Jung. Nel suo libro autobiografico Ricordi, sogni, riflessioni, nel capitolo X (Visioni), Jung descrive una sua esperienza liminale, in seguito un infarto del miocardio subito nel 1944:
“Nello stato di inconscienza ebbi deliri e visioni, che han dovuto avere inizio quando versavo in imminente pericolo di morte (…). Mi pareva di trovarmi in alto nello spazio celeste. Sotto di me vedevo il globo terrestre avvolto in una splendida luce azzurra. Scorgevo il mare, intensamente azzurro, e i continenti (…). Il mio campo visivo non includeva tutta la terra, ma la forma sferica di questa era chiaramente riconoscibile, e i suoi contorni brillavano come argento in quella meravigliosa luce azzurra.”.
Jung descrive nei particolari le varie tonalità di colore presenti nei punti del globo che ammira dall’alto, dal verde scuro all’argento ossidato, al giallo-rosso del deserto arabo.
Inutile sottolineare la strepitosa somiglianza di questa visione con quella platonica. Un dettaglio che non mi pare sia stato sottolineato neanche da Pugliese Carratelli è il passaggio in cui Jung, dopo avere descritto nei dettagli la visione della terra, aggiunge:
“Non guardai verso destra. Sapevo che ero in procinto di abbandonare la terra”.
Forse un particolare casuale, ma è interessante ricordare che la destra è proprio la direzione verso cui le anime dei defunti iniziati procedono per raggiungere la dimensione di beatitudine a loro riservata, i “prati di Persefone” citati espressamente in una famosa laminetta aurea trovata in una sepoltura di Thurii (vedi Fenix n. 35 ).
Jung pare non essersi mai accorto in prima persona del parallelismo tra la sua esperienza e quella narrata nel Fedone; nonostante ciò nella sua ekstasis comparve un diretto legame con il mondo greco. Infatti, nella visione ad un certo punto
“… accadde qualcosa che richiamò la mia attenzione. Dal basso, dall’Europa, una figura veniva verso l’alto. Era il mio medico, o meglio la sua immagine, cinta di una catena d’oro o di un’aurea corona d’alloro. Lo riconobbi subito: “Ah, è il mio medico, quello che mi ha curato. Ma adesso viene nella sua forma originale di un basiléus di Cos. Nella vita egli era un avatara di questo basiléus, la temporanea incarnazione della forma originale, che esiste da tempo immemorabile. Ora viene nella sua forma originale”.
Il medico, in forma telepatica, annuncia a Jung di essere stato mandato dalla terra a portargli un messaggio: non poteva lasciare il nostro pianeta, e doveva ritornarvi. Così si conclude la visione narrata da Jung.
Che nell’inconscio del medico Jung sia emerso un legame con Cos, la patria di Ippocrate, il più famoso medico dell’antichità, non appare strano. Molto interessante, invece, è che Jung designi questo medico con il titolo di basiléus. Infatti solo gli antichisti sono a conoscenza del dibattito sul significato dei cosiddetti basileis di Cos, un collegio di sacerdoti/guaritori, citato nei racconti mitologici ma attestato una sola volta in un’iscrizione del IV secolo a.C. Sarebbe interessante scoprire come questo dettaglio sia venuto a conoscenza di Jung, che pure aveva grandi frequentazioni con specialisti delle religioni antiche e con la classicità.
Un sottile legame sembra correre tra queste visioni straordinarie che affiorano in alcune narrazioni. E dunque, quel “a quanto dicono” (in greco Os leghetai), con cui Socrate introduce il racconto sulla visione della Terra dallo spazio, sembra alludere a un complesso di tradizioni che possono avere avuto alla fonte la relazione di un’ekstasis autentica, e la testimonianza di Jung sembra dimostrarcelo. Al racconto di Jung si può anche aggiungere, come nota Carratelli, l’esperienza provata da Auckland Geddee, un altro medico e parapsicologo, che in punto di morte sperimentò
“il trovarsi libero in una dimensione temporale dello spazio”.
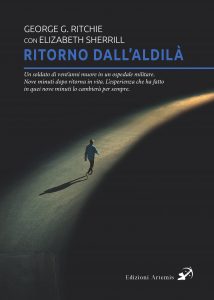
Ma, al di là dell’esperienza fenomenica, è possibile ipotizzare un modello rituale originario e, in caso affermativo, dove può essere cercato? Nella Grecia antica devono essere esistite tecniche “magiche” per produrre stati di ekstasis, accompagnati alle dinamiche tipiche della catalessi: ce lo suggeriscono tutte le tradizioni che attribuiscono a maestri di vita e iatromanti semimitici come Epimenide, Aristea di Proconneso, e a sapienti come Empedocle e Pitagora, la capacità di penetrare in dimensioni extratemporali e extracorpore. Questo complesso di tradizioni, spesso aggrovigliato, stratificato e travisato già in antico, non va confuso con la magia di bassa lega, o l’esoterismo a buon mercato che lo stesso Platone condanna nella Repubblica, quando parla dei profeti itineranti e della loro catasta di libri attribuiti ad Orfeo.
Il Fedone è un’opera immersa in un’atmosfera “pitagorica”, a partire dagli interlocutori di Socrate, “ i due Pitagorei di Beozia”. Sembra probabile che lo stesso Pitagora praticasse la catabasi rituale, come strumento per un’elevazione della conoscenza e fondamento della sua dottrina originaria. Alcune fonti, tra cui una di taglio parodistico (Ermippo) affermano che il filosofo samio si fece costruire una camera sotterranea nella quale si rinchiuse, ricevendo comunicazioni dal nostro mondo tramite “la madre” (allusione al culto di una divinità femminile, forse Demetra?). Ma le attestazioni, come dicevamo, riguardano anche altri personaggi: Epimenide di Creta dormiva per alcune decine di anni nella stessa caverna dove Minosse visitava il padre Zeus (Senofonte, 21B20 D.-K.). Esperto in catalessi, Epimenide avrebbe accompagnato Pitagora nella caverna dell’Ida (Diogene Laerzio XVIII 3),e, secondo Plutarco, la sua incubazione sarebbe durata 57 anni (altre riflessioni andrebbero fatte sui numeri che vengono riportati dalle fonti, ma la discussione ci porterebbe lontano). All’uso, come alimento, di una pianta chiamata alimos le fonti antiche attribuiscono anche la longevità di Epimenide. Importante ribadire che durante le catalessi l’anima del mistico greco visitava gli dei, ascoltava i loro discorsi e si trovava ad essere in presenza della Verità e della Giustizia (Massimo di Tiro, X, 1). Si afferma, dunque, in maniera chiara, il legame tra le esperienze estatiche di morte apparente e un aumento di conoscenza da parte di chi le prova, oltre che il fondamento gnoseologico del suo messaggio.
L’anima di Ermotimo di Clazomene lasciava spesso il corpo “in uno stato intermedio tra morte e vita” per recarsi in luoghi lontani, dove registrava i fatti locali (Plinio, Naturalis Historia VII 104). Un altro viaggiatore estatico, Aristea di Proconneso fu protagonista di un famoso episodio di morte apparente narrato da Erodoto, con successiva sparizione del corpo e ubiquità. Sei anni dopo la sparizione, Aristea ritornò a Proconneso, compose il suo poema Arimaspeia, e scomparve per 240 anni. La testimonianza, più tarda, di Massimo di Tiro, precisa che l’anima di Aristea avrebbe avuto la facoltà di abbandonare il corpo sotto forma di uccello (un corvo, secondo Plinio N. H. VII 174) e che nei suoi viaggi estatici avrebbe percorso enormi distanze, spingendosi fino alle popolazioni Iperboree.
Tutte queste fonti andrebbero discusse nel dettaglio. In ogni caso, sia che si tratti di recuperi di resoconti genuini, sia di rielaborazioni successive (ma comunque già a partire dal V secolo a.C., come attesta Erodoto), si può ipotizzare che proprio nell’ambiente legato a Pitagora possa essersi formata una tradizione di riti e conoscenze fondate su esperienze di ektasis. Tali esperienze sarebbero state poi sistematizzate in una dottrina coerente e organica come quella della metempsicosi o metensomatosi, la trasmigrazione delle anime. Una dottrina nella quale era fondamentale la componente della mneme, della capacità memoratrice, in grado di rievocare le esistenze passate tramite una rigorosa pratica di vita che implicava la padronanza dell’ascesi. L’interesse della scuola pitagorica per la scienza astronomica potrebbe poi avere giocato un ruolo nella elaborazione del contenuto cosmologico di alcune di queste visioni, come quella, appunto, della “vera terra”. Tutti questi indizi lasciano pensare che il rapporto tra la visione narrata da Socrate nel Fedone e la scuola di Pitagora fosse tutt’altro che marginale.




