di Claudia Tinaro
(PICCOLO DIARIO DI BORDO DI UNA GIOVANE NAVIGANTE NEL MARE MAGNUM DEGLI ENTI E DEI GRUPPI STEINERIANI)
Non voglio che sia un articolo, ma che sia una storia, perché non voglio denunciare, ma raccontare.
Liberi di leggere queste parole in fila; soprattutto, liberi di credere a questa versione dei fatti. Io, semplicemente, scrivo e per due motivi: 1. perché, in alcuni casi, ne salva più la penna che la psicologia; 2. perché, con certo coraggio, può fare luce più la parola che il silenzio.
Ecco, allora, il mio diario di bordo nel mare magnum dei gruppi di lettura e degli enti di formazione antroposofici dove, in molti, hanno smarrito la bussola e hanno perso il Nord, perché la stella del mare s’è fatta stella del male.
Il primo giorno in cui ho varcato la porta di un mondo antroposofico ho messo piede in una piccola realtà di formazione in discipline artistiche con fini terapeutici. Faccio un passo, poi un altro e, sotto di me, trovo un tappeto vetusto che copre un pavimento consumato. Mi trovo in uno spazio anonimo: un appartamento qualunque, dai contorni squadrati e le pareti stinte. Mi guardo intorno: un mobilio raffazzonato, recuperato chissà dove; qualche stampa colorata e pure sbiadita; una immagine a carboncino neppure veritiera di Rudolf Steiner. Attraverso le stanze: tavoli sgangherati, sedie antiquate, qualche pianta senza fiore.
Poco o nulla riverberava di una possibile o attesa “architettura organica vivente”. Tutto, al contrario, tendeva ad essere disomogeneo e decadente. Eppure, sapeva tanto di casa di Zia Carmela che, la mia parte bambina, ha finito per farsi incantare e illudere da quell’atmosfera tutta “puzza di vecchio” e “sapore di cioccolata”. Orsu’, come Cappuccetto Rosso, avevo appena scambiato il lupo per la nonna…nonostante vedessi quegli occhi grandi e quelle orecchie enormi!
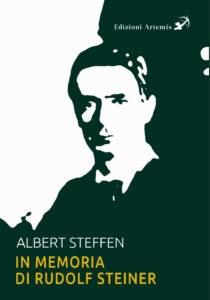
Estivano e tessevano i fili intrecciati di questo spazio giovani dipendenti e anziani volontari, in un’atmosfera di apparente equilibrio tra formali sorrisi e compromessi silenzi. Si lavorava e si cooperava in un ambiente quasi casa, forse, quasi chiesa. Tutto, infatti, sapeva di quel “non so che di salotto tra tazze spaiate e coperte all’uncinetto; e, pure, di quel “non so che di sagrestia, tra quattro Ave Maria in croce e quattro pettegolezzi da vizzoga”, (tradotto dall’abruzzese, “bigotta”). Io sarei diventata, dopo un indescrivibile e diseducativo affiancamento, una dipendente e, per le tante ore spese e trascorse al suo interno, anche una volontaria. “Un doppio legame”, per dirla con Bateson.
Sia per i dipendenti che per i volontari l’apprendimento delle procedure e delle mansioni avveniva attraverso una comunicazione intrisa di schematicità ai limiti del meccanicismo: si-fa-così-senza “se” e senza “ma”. Di fatto, per quanto reiterate e trasmissibili in teoria, procedure e mansioni acquisite risultavano di difficile o impossibile applicazione nella pratica. “ Tra dire il fare c’è di mezzo e il “ cantavano Elio Le Storie Tese; direi, in questo caso, tesissime.
Ci si trovava, difatti, in un contesto confuso e fumoso in cui non era mai chiaro, né mai chiarito chi, fa, cosa. Il che, aveva comportato, nel corso del tempo, una vera e propria anarchia: chiunque era passato di lì come dipendente o volontario aveva fatto la tale cosa, in tale modo, con tale procedura, trascritta e archiviata per i posteri i quali, però, avrebbero occupato la stesso posto e lo stesso pc, ma in un altro tempo e in altre circostanze: altra presidenza, altra amministrazione, altre regole, altre forme. Così facendo, tutto veniva rimesso in discussione, riformulato ex novo e, quelle che venivano definite regole, elencate in regolamenti, diventavano vademecum immanenti. Io stessa li stilavo daccapo, poi li cancellavo in parte, mi ci attenevo in modo pedante, ma fino alla prossima modifica. “Scripta volant”, letteralmente o quasi.
Il risultato? Un ambiente relazionale e lavorativo disorganizzato e disorientante, cesellato di lacune formative e informative. Eppure, laddove si tentava con la propria intelligenza e perspicacia di portare chiarezza o colmare vuoti, chissà perché, si veniva accusati di eccessiva autonomia o ingiustificata intrusione. Non si contano le volte in cui sono stata ostacolata nel chiedere aiuto o delucidazione, specie se a soggetti o enti di grado superiore…perché? Oppure, ostacolata nel creare contatto e comunicazione specie se tra persone e collaboratori di certa valenza…perché? Per timore di ledere l’immagine ostentata o svelare l’incompetenza effettiva? Domanda lecita, col senno di poi.
Ora, in una realtà in cui le regole si trascrivevano in procedure sempre modificabili e gli obiettivi si perdevano in un fare sempre prioritario, non rilevava altro che una mancanza di pianificazione e visione di insieme. Va da sé che, senza chiarezza né prospettiva, l’inserimento e l’adattamento di una persona al suo interno diventavano difficili quanto impossibili. Nella fattispecie, questa difficoltà veniva giudicata, in parte, come un’incapacità e una mancanza dei dipendenti: magari perché aventi «un temperamento troppo flemmatico oppure troppo sanguinico», a detta di chi sedeva in alto. E, anche in questo caso, a nulla valeva provare a mettere in luce l’effettiva assenza di una mission associativa o, più umilmente, provare a suggerire una possibilità di pianificazione almeno quotidiana. Bene, anzi, male; più precisamente, maleducazione che, reiterata per 12 lune, si fa maltrattamento.
Era palese il darsi da fare nel vuoto e per il niente in un contesto così rigido e immobile che, lentamente, aveva trasformato le persone in un meri esecutori di ordini senza un “un sapere-fare” e senza priorità alcuna, se non l’urgenza imposta per volere insensato. All’ordine del giorno, infatti, erano le “richieste impossibili”: quel presumere che si sapesse fare qualcosa che non era mai stato fatto prima, per la quale non si era stati formati mai; e pretendere che lo si facesse, a prescindere, come qualcosa di urgente e necessario, ma senza fornire istruzioni chiare o supporto relativo. Insomma, un “problem solving test”: superato appieno ogni sacrosanta volta, ma a costo di un certo stress che, reiterato per dodici lune, si fa esaurimento.
Ad ogni luna nera, in prossimità di quella insopportabile stanchezza mentale e fisica conseguente ad ore e ore di lavoro davanti un pc lento, su una sedia scassata, in una stanza rumorosa, immancabile la voce quieta e suadente degli assisi ai vertici: «Beh, la vita è questa: imprevisti e prove, prove ed imprevisti: del resto, siamo in piena Epoca di Michele». C’era del vero, si. Ma c’era del falso, anche: mascherare in “prova individuale” da superare con capo chino e in religioso silenzio una disorganizzazione e una disarmonia interne di cui non ci si voleva assumere la responsabilità nessuno.
Il pane quotidiano richiedeva di ingerire bocconi amari o pesanti, ma anche di osservare e sottostare ad atteggiamenti compulsivi a metà tra l’indifferenza e la svalutazione, alternate alla considerazione e alla complimentazione, nel giro di una settimana. Un giro di giostra ai limiti della nausea, fisica ed interiore: oggi sei un disastro; oggi sei in gamba; rimproveri e carezze; bastoni e carote, ma senza ratio. Nel mezzo, un pizzico di silenzi punitivi quando si provava a manifestare il proprio malcontento, e una pacca di belle moine quando si abbassava il proprio sguardo. Così, ogni giorno, si viveva sull’altalena dei pensieri e delle emozioni proprie di chi non sa più cosa è bene o cosa è male che si faccia e che si dica. E, quel “chi”, in pratica, ero io.
E’ bene o è male salutare con cortesia un docente o offrire un caffè al Tesoriere? Credo sia un bene; ma perché, allora, quell’occhiata storta, quel saluto contratto e questa freddezza e questo distacco nei miei riguardi, stamane? E’ solo una mia impressione? Sarà. Ma siamo davvero a questi livelli di comunicazione in questo piccolo mondo di formatori ed educatori? Alla faccia dell’empatia.
E’ un bene o un male scambiare quattro chiacchiere con la tirocinante di turno, o uscire a pranzo con una volontaria, oppure ospitare in casa una delle partecipanti ad uno dei corsi? Credo non sia un male, soprattutto per una realtà fatta di persone e di relazioni; ma perché, allora, sono stata esclusa da quella riunione di segreteria, o maltrattata al telefono quel giorno, o non avvisata in tempo dell’aperitivo di saluti prima delle vacanze di Natale? E’ solo la mia sensibilità a notare certi dettagli? Sarà. Ma siamo davvero a questi livelli di relazione in questo ente formativo che sbandiera riconoscimenti e apprezzamenti dalla Cupola di Dornach? Alla faccia dell’etica.

Ad ogni tentativo di chiedere una spiegazione circa questi comportamenti “bipolari”, reiterati ogni qualvolta il mio modo di essere e fare urtava contro gli angoli spigolosi del cuore ferito di qualcuno della direzione o dell’amministrazione, la risposta è stata sempre e comunque dirottata verso la critica o la negazione.
La critica: «Oh, su, la prendi troppo sul personale; la prendi troppo sul serio; ci metti troppo cuore; ci dedichi troppa attenzione; ma quanto sei sensibile; ma quanto sei emotiva; ma quanto sei suscettibile»: da una certa prospettiva, questo non era altro che un subdolo modo di prendere in mano la mia sensibilità, strizzarla come un mocio della Wileda e calpestarla come le foglie d’autunno. Risultato: il serpeggiare stridente di un senso di inadeguatezza e di colpa rispetto il mio sentire: ma sono davvero troppo così?
La negazione: «Ti è stato detto questo? Ma cosa dici! Hai capito male – Ti è stato fatto questo? Ma davvero? Hai sbagliato tu – Ti era stato chiesto di fare così, non colà, rifai. Anzi, però, adesso fai colà, non così. Sei confusa? E’ normale. Qui, si rasenta la follia»: sotto certi aspetti, questo non era altro che un furbo modo di creare confusione nella mente e nei ricordi, e cancellare le tracce degli eventi e dei fatti. Risultato: la continua ed estenuante messa in dubbio delle mie percezioni e della mia memoria: ma sul serio ho capito male o ricordo male?
Ho spesso chiesto ai colleghi di lavoro semmai notassero quella ambiguità comunicativa, quel modo di negare il detto o di confondere i fatti da parte di chi teneva strette le redini sfilacciate di un potere fatuo. E, in nessuna occasione ho trovato appoggio o sostegno, se non l’invito a lasciare stare, a lasciare essere. “Adda passà ‘a nuttata”, diceva De Filippo.
Nottata lunga, buia, fatta di ombre, intrisa di dubbi, costellata da mal di testa e di pancia, tonsilliti e faringiti; infuocata di rabbia e rancore che, inevitabilmente, trovavano vie di fuga e di sfogo attraverso i pori della pelle, il sale degli occhi e i graffi della voce. L’Io dinanzi al Male: ero, nel mio piccolo cosmo, dinanzi a questa grande soglia.
In fin dei conti, l’incontro con il mio doppio è stato inevitabile e necessario. A dire il vero, è stato anche distruttivo e deleterio perché ogni volta che la mia parte reattiva e incontrollata si manifestava con voce grossa e parole dure, i comportamenti e gli atteggiamenti nei miei riguardi sono stati, in modo alterno, di giudizio, di controllo e di isolamento. Il mio temperamento doveva essere domato e punito. Tant’è.
In questo modo, si scatenava altro che una guerra intestina ed egoica tra maschere e copioni: datore e dipendente, dipendente e volontario, allievo e docente, giovane e vecchio: vittima e carnefice. Alla fine, almeno per me, vinceva il silenzio e la resa davanti allo specchio del proprio Sé. Un Sé frantumato.
Nel mentre, l’unico spazio di ascolto e di comprensione che ho trovato è stata la risma di fogli su cui ho iniziato ad appuntare, giorno dopo giorno, dialoghi, gesti e silenzi per mettere nero su bianco le menzogne e le contraddizioni di una comunicazione e di un atteggiamento ai limiti della manipolazione e della distorsione della realtà. Della realtà oggettiva dei fatti, e della realtà soggettiva delle percezioni.
Scrivere, dunque, è stato uno strumento terapeutico che ha permesso un rispecchiamento salvifico: mettere in ordine i pensieri e su carta le emozioni equivaleva a fare dell’azione delle dita della mano un mezzo di estrinsecazione del pensiero e di acquietamento del sentire.

Nel frattempo, ad ogni luna storta, risuonava nell’etere l’aforisma del giorno di Rudolf Steiner, estrapolato da qualche sito web o da qualche serata antroposofica del giovedì sera e, immancabile, il giudizio imperante: «sei troppo nell’astrale, troppo nel sentire, con tante distrazioni; dovresti prendere ad esempio i tuoi colleghi, lucidi, distaccati, con una grande morale». In parte era un’osservazione veritiera; in parte era un’affermazione manipolatrice: di nuovo, una mia qualità veniva prima messa alla prova e sotto pressione e, poi, giudicata per il suo emergere in modo decentrato o eccessivo. Spremi un bel limone fino all’ultima goccia e, poi, dì pure che il succo è troppo aspro, quasi imbevibile, quindi da sputare.
Ancora, scrivere si è fatto un atto necessario: in quel marcio angolo del mondo antroposofico non c’era nessun pensiero vivente a farsi Luce alla Menti, ma solo pensieri morti a irradiare Luci a Gas capaci di intossicare e confondere il buono, il bello e il vero. Scrivere, dunque: per diradare la nebula del caos e ri-delineare i contorni del reale.
Luci a gas: “gaslight”: il titolo di un vecchio film di George Cukor con Ingrid Bergman: la storia di una giovane coppia e delle derive psicologiche della manipolazione. Dal soggetto narrativo è stato estratto, non a caso, il termine “gaslighting” per indicare una tecnica manipolatoria oramai parte dei manuali di psicologia clinica: negare i fatti, insinuare colpe, confondere la memoria, destabilizzare la sicurezza, mettere in dubbio le capacità e le percezioni… esattamente tutto ciò che in 12 mesi ha scavato i miei occhi, confuso la mia mente, strizzato il mio cuore, infuocato la mia pelle, lentamente e costantemente, come una goccia cinese.
E, goccia dopo goccia, in un primo momento, credi a ciò che ti si dice o che ti si impone: devi cambiare, perché così come sei e come fai non vai bene. Tu ci provi, seppure lo trovi innaturale e ingiusto sotto certi aspetti: essere e fare come loro vogliono che tu sia e tu faccia. Ma, alla fine, cosa ti costa? Osservi che se sei e se fai quasi essendo invisibile, e quasi facendo nulla, allora hai valore e riconoscimento: lusinghe e apprezzamenti iniziano a fioccare come neve ad agosto e ti pare un Miracolo di Fatima. Ma, in fondo, cosa senti? Di soffocare il tuo essere e di snaturare il tuo fare. Prima o poi, la pancia non riuscirà più a digerire ciò che il cuore non saprà più accogliere; la gola si chiuderà in un silenzio soffocante e la testa si affastellerà di pensieri confusi. Allora, perderai il centro e cadrai ora a destra ora a manca, in balia della tristezza e della rabbia, della confusione e dello smarrimento. Poi, un giorno, esploderai e, per questo, verrai etichettata e punita; soprattutto darai ragione proprio a coloro che ti dicono che “non vai bene”, perché, difatti, così, con questo fuoco e questo dolore sotterranei, rischi di bruciare te stessa e il mondo intorno.
Ecco quanto costa farti sottomettere e svalutare in cambio di quattro soldi o quattro carezze: entrare nell’ingranaggio malefico di una profezia autoavverantesi. Ma perché e per cosa tutto ciò? Lasciarmi comandare senza spiegazioni come un soldato, o educare con la menzogna come una bambina, o destabilizzare senza ritegno nell’integrità, per poi implodere di rosso o esplodere di fuoco ed essere rimproverata e giustiziata per questa reazione in parte istigata e fomentata: non equivale, forse, a recitare e reiterare il copione di un soggetto scritto apposta per mettere in scena e a nudo il mio ego vittimistico? Dunque, “A che gioco sto giocando?”, per citare Berne.
Laddove c’è un vittima, c’è sempre anche un carnefice e c’è sempre anche un salvatore. E, nel corso delle dinamiche di questa triangolazione relazionale, i ruoli si scambiano e si intersecano secondo modalità e con reazioni che la psicologia e la psichiatria ha analizzato in modo completo ed esaustivo. Ma io non sono qui per fare della didattica, bensì per raccontare una storia dalla prospettiva della vittima, senza denunciare il carnefice, né giustificare il salvatore. Una storia di abuso di potere di cui sono stata co-responsabile in quanto co-protagonista, seppure in modo inconsapevole e incosciente, fino ad oggi.

E, questo, in un ambiente antroposofico che si reputa votato al Bene-Essere, seppure abitato da persone che si definiscono formatori di qualità: cosa alquanto preoccupante giacché gli strumenti dell’educazione, se veicolati da esseri umani irrisolti e incongruenti che hanno indorato la pillola amara delle loro ferite emotive appellandosi e aggrappandosi, in modo illusorio e deviante, alle parole del Maestro per farne un giustificativo e un palliativo egoico, allora risultano malsani se non malevoli.
Non solo. Un ambiente antroposofico che si vuole votato all’etica, ma in verità gestito da persone che non sempre valorizzano la chiarezza comunicativa, bensì l’ambiguità ai limiti dell’inganno; che quasi incoraggiano il contributo individuale, bensì ostacolano l’iniziativa intraprendente e, lo fanno, con sottile invidia e paura.
E, infine, un ambiente antroposofico che ci si aspetta il più possibile “sano” ed “equilibrato”, mentre si permette che vi passino indisturbati individui dal cuore ferito mai sanato e in nessun modo: un buco emotivo che ha creato lo spazio vitale per uno squilibrio interiore, scambiato per carattere radicato e, così, giustificato come atteggiamento personale. Invero, esso può delineare i contorni patologici di un disturbo narcisistico più o meno nascosto che assume un peso grave, per non dire greve, in un contesto che si definisce “spirituale” alias “evolutivo”, a cui approdano anime spesso tormentate o deboli, alla ricerca di se stesse.
Certo, in ogni mondo e in ogni ambiente, in ogni uomo e in ogni cuore, vi sono luci e vi sono ombre. Ma queste ultime, ad un certo punto, quando irrompono il dolore e la sofferenza in qualunque forma, bisogna pure avere il coraggio e l’umiltà di guardarle ed accoglierle.
Guardarsi allo specchio fa paura e vergogna, è doloroso e insopportabile, ma non c’è altro modo per iniziare a lavorare su se stessi: e’ un passaggio obbligato sulla strada della crescita interiore. Perciò, se questo squarcio avvelenato del mondo antroposofico si è fatto specchio del mio copione, del mio ruolo, del mio ego, allora, col senno e col senso del poi, è stata un’esperienza destinata e una necessità karmica a cui, nel tempo e nello spazio del futuro, andrà la gratitudine e la riconoscenza dal cuore. Ma, questo, solo dopo avere messo in luce e tirato fuori tutta la rabbia, il risentimento e la delusione perché, in caso contrario, sarebbero solo una gratitudine ed un riconoscimento intrisi di quella morale bigotta che guarda al Gesù in Croce e non al Cristo nella Luce.
Intanto, decido di andare via. Le mie scarpe, per l’ultima volta, sfiorano quel tappeto all’ingresso come fosse il portale di accesso ad un’altra dimensione: vorrei vedere quanta polvere di pensieri fumosi, parole vane, promesse infrante e pettegolezzi maligni ha raccolto e nascosto tra le sue trame, in questi anni, tra pause lezione, pause caffè, saluti e abbracci, arrivi e partenze. Mi sovviene, allora, il titolo di quel romanzo beat del mio conterraneo Fante: “Chiedi alla Polvere”…non della strada, ma delle memorie di un mondo che, per la sua vacuità e la sua inconsistenza, può sparire e diradarsi con un soffio.
Soffio sulla candela sempre accesa sotto l’immagine dell’Arcangelo Michele, chiudo la porta e butto la chiave. Il portale si chiude. Quella dimensione scompare.
I gruppi antroposofici non sono stelle polari: non è detto che sappiano indicare il Cielo del Nord al ricercatore dello Spirito. Sono, forse, soltanto una costellazione di uomini con il loro ego ancora irrisolto e, per di più, irrigidito da un attaccamento al ruolo e all’immagine di “antroposofo” : un sostantivo-aggettivo che si fa nominativo e qualificante di una eterea e, a volte, delirante intenzione di farsi e proporsi come maestri.
Ciò detto, bisognerebbe imparare a distinguere e soppesare in modo differente i limiti degli uomini con i principi dell’Antroposofia perché, altrimenti, si butterebbe via l’acqua sporca e pure il bambino innocente. Del resto, vi sono ancora uomini e donne di mente acuta, grande cuore e buona volontà tra i ricercatori della Scienza dello Spirito ma, non a caso, lontani e indipendenti dai cerchi dell’Antroposofia di Dornach. Uomini non maestri. Allora, è tra i singoli individui e non tra i tanti gruppi che si potrebbe o dovrebbe cercare la Stella Polare ad orientare il cammino interiore.
Questi circoli colore pastello che anelano a farsi e proporsi come comunità spirituali, del resto, sono oasi allucinate nel deserto o illusioni ottiche alla Penrose: prima o poi si rivelano per ciò che sono: congreghe, parrocchie, chiese in cui si officiano rituali con candele di cera d’api, tessuti di cotone naturale, verghe di rame e scarpette in similpelle, alle scadenze del calendario dell’anima. Forme forse ancora aderenti al bello, ma oramai svuotate del vero. Forme immagine e forme pensiero del tutto avvelenate.

“Chi ha avvelenato Rudolf Steiner?”, scrive Andrea Franco. Credo che questa domanda vada di nuovo posta, ma coniugata al presente, perché il veleno scorre ancora.
Zia Carmela diceva che l’antidoto più potente ed efficace era la preghiera a Santa Rita o l’ex voto a San Gabriele: contro il veleno ci voleva un miracolo.
La mia terra, di molti eremi e pochi santi, neppure abruzzesi, mi ha insegnato che il miracolo è possibile soltanto per gli uomini e le donne di buona volontà. E, per i miei occhi di bambina, questi uomini erano i monaci eremiti tra le pietre della Majella, che praticavano il digiuno e il silenzio, predicavano il Vangelo ai pellegrini e ai viandanti e si ispiravano alla vita e alle parole di Pietro da Morrone; erano i contadini ricurvi tra peschi, fichi e filari di uva, che aspettavano la luna nuova del raccolto, saggiavano con le dita il vento della semina e andavano in pellegrinaggio a Fara: perché la pioggia, quando manca, la si invoca… a Sand’ Martine (San Martino); erano le vecchie e le vedove vestite di nero che raccontavano le storie dei santi davanti il focolare, sgranavano il rosario mentre lievitava il pane e toglievano il malocchio con acqua, olio e tre segni della croce, “Padre, Fiije e Spirite Sante” (Padre, Figlio e Spirito Santo).
Oggi, con altri occhi, osservo che quella volontà del fare, dei piedi incalliti, delle schiene spezzate, delle mani nodose, pure avvolta dalla fede e dalla devozione delle mani giunte all’altezza del cuore, adesso non basta: ci vuole una volontà illuminata dalla comprensione spirituale, la quale, tuttavia, appare ancora e sempre un grande mistero. Allora, nessun miracolo?
In viaggio di ritorno, mentre scorre davanti ai miei occhi il profilo rosa-blu della Grande Maja che domina la Valle del Sangro, mi sovvengono al cuore le parole di Massimo Scaligero:
«Il miracolo è sempre a disposizione di chiunque sia capace di una certezza appassionata, a cui risponda la forza del cuore, come forza di donazione assoluta di sé (…). Il miracolo è possibile in ogni momento, anche quando i decreti naturali ed umani sembrano affermarne l’impossibilità. Il cuore vince la Terra, quando fa sgorgare da sé la forza del Cuore del Mondo.»
Dedicato a Roberto A., Andrea B., Fabio B., Angelo F., Enzo N., Francesco L., Leonardo M., Piero C., Piero P., e a tutti gli uomini stra-ordinari incontrati lungo i Sentieri dell’Antroposofia, grazie ai quali guardo ancora alle stelle e credo ancora nei miracoli.

Claudia Tinaro. Diplomata in Ragioneria, laureata in Comunicazione Multimediale ma con una tesi in Storia del Teatro su “Lo Spazio Vuoto” di Peter Brook e “la Quarta Via” di George Gurdjieff. Segretaria per necessità, ma scrittrice per passione: prima correttrice bozze ed editor; in seguito ghostwriter e copy; ancora, una parentesi nel web e nei social che le ha permesso di iniziare ad indagare e studiare gli effetti sociali delle nuove tecnologie. Poi, lo spartiacque del Covid e un perdurante stato di malessere psicofisico che l’ha messa dinanzi alla prova più dura, e alla ricerca di una guarigione più profonda: allora, ha conosciuto il potere terapeutico della scrittura creativa e della scrittura biografica. Dopo un’esperienza di burn-out ed un invito del destino, ha deciso di lasciarsi alle spalle il front office e la partita doppia per dedicarsi appieno alle parole che curano, approfondendo la scrittura terapeutica e la medicina narrativa.




