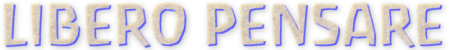di Andrea Zhok
Tra le varie analisi sbilenche del voto europeo c’è n’è una, diffusissima, che lega il (relativo) progresso dei partiti di destra o nazionalisti nel panorama politico all’atmosfera bellicista, secondo la logica che associa la destra alla temperie guerrafondaia.
Si tratta di un’analisi che oltre a esprimere una preoccupante cecità alla realtà, risulta particolarmente dannosa. Essa infatti fornisce l’ennesimo alibi ai molti benpensanti, che continuano a leggere la politica con categorie binarie di cent’anni fa (sinistra – destra, progresso – reazione, pacifismo – bellicismo, ecc.). Ora, se c’è una cosa chiara è che le forze politiche che più hanno alimentato il bellicismo nel panorama europeo sono state forze di centro (i “moderati per la nuclearizzazione”, tipo la von der Leyen) e forze sedicenti progressiste, di sinistra o centro sinistra (dall’SPD di Scholz, a Renaissance di Macron, ai Verdi della Annalena Baerbock.)
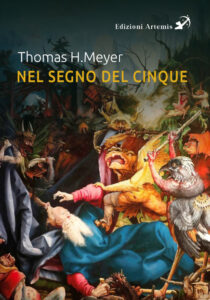
Le forze di destra premiate dalle elezioni sono quasi tutte (l’unica significativa eccezione è la nostra Meloni) contrarie alla guerra, contrarie a spedire armi all’Ucraina, contrarie alle sanzioni alla Russia (non per russofilia, ma perché consapevoli che danneggiano più noi che la Russia).
Anche dove la destra al governo non viene premiata, come in Ungheria, essa è sfidata su questioni di corruzione interna, non sulla linea politica. Accade così che in Ungheria i due primi partiti siano Fidesz con il 46% seguito da Tisza, guidato da un fuoriuscito da Fidesz con il 31%, con un’agenda di politica estera indistinguibile da quella di Orban. La minaccia della guerra e il contenimento dell’autolesionismo economico dell’Europa sono i punti su cui la destra ha vinto, dove ha vinto.
Che su questi temi la sinistra non riesca a battere un colpo da tempo è un dato su cui meditare.
Negli eredi storici dei partiti socialisti e popolari – oltre che nei Verdi – oggi prevale un atlantismo ottuso, una visione manichea e fortemente ideologizzata della storia e della politica, prevale soprattutto una visione del mondo sconcertantemente astratta, che ha perso ogni contatto con il senso comune prima ancora che con i beni comuni.
E’ quell’astrattezza europea che mette a posto le sedie del Titanic (con eroiche battaglie su diritti LGBTQ, auto elettriche e certificazioni termiche) mentre ci prepara alla guerra col sorriso sulle labbra (la CO2 fa malissimo, ma quanto alle radiazioni ionizzanti e all’uranio impoverito, ecchessarà mai).

Le forze di destra che escono vincitrici, come l’AfD o, con agenda molto più annacquata, il Rassemblement National della Le Pen, non rappresentano però delle risposte realistiche al disorientamento corrente dell’elettorato.
Sono qualcosa di più di un mero voto di protesta, ma qualcosa di meno di un voto per un’alternativa.
Nonostante qualche segno interessante, come il buon successo del Bündnis Sahra Wagenknecht in Germania, di un’alternativa programmaticamente solida non si vede ancora traccia.
***
Comunque l’elezione al Parlamento Europeo di Ilaria Salis è la prova provata che con il governo dei media si può ottenere qualunque risultato, e che per chi è fuori dal giro non ce n’è.
La sig.ra Salis ha come curriculum semplicemente di essere stata arrestata in un Paese che nella rappresentazione mediatica mainstream è bruttobruttobrutto.
Su questo punto si sono confezionate storie atte a toccare le corde emozionali del pubblico che non si interessa di politica “che è tutto un magna-magna” e/o che comunque non ne sa nulla, se non le narrative mummificate di un secolo fa (antifascismo o anticomunismo come fiabe sempreverdi che esimono dal pensare).
Confezionato il pacchetto con il fiocchetto della “vittima” (il “vittimismo” è l’unica ideologia rimasta) il resto lo fanno i riflessi pavloviani.
 Andrea Zhok, nato a Trieste nel 1967, ha studiato presso le Università di Trieste, Milano, Vienna ed Essex. È dottore di ricerca dell’Università di Milano e Master of Philosophy dell’Università di Essex. Oltre a saggi ed articoli apparsi in Italia e all’estero, ha curato scritti di Simmel (Il segreto e la società segreta, 1992) e Scheler (Amore ed odio, 1993). È autore di Intersoggettività e fondamento in Max Scheler (La Nuova Italia, Firenze 1997), Fenomenologia e genealogia della verità (Jaca Book, Milano 1998), Introduzione alla “Filosofia della psicologia di L. Wittgenstein (1946-1951) (Unicopli, Milano 2000) e L’etica del metodo. Saggio su Ludwig Wittgenstein. (Mimesis, Milano 2001). Attualmente collabora all’attività didattica e di ricerca presso le cattedre di Filosofia della Storia e Filosofia Teoretica II dell’Università degli Studi di Milano.
Andrea Zhok, nato a Trieste nel 1967, ha studiato presso le Università di Trieste, Milano, Vienna ed Essex. È dottore di ricerca dell’Università di Milano e Master of Philosophy dell’Università di Essex. Oltre a saggi ed articoli apparsi in Italia e all’estero, ha curato scritti di Simmel (Il segreto e la società segreta, 1992) e Scheler (Amore ed odio, 1993). È autore di Intersoggettività e fondamento in Max Scheler (La Nuova Italia, Firenze 1997), Fenomenologia e genealogia della verità (Jaca Book, Milano 1998), Introduzione alla “Filosofia della psicologia di L. Wittgenstein (1946-1951) (Unicopli, Milano 2000) e L’etica del metodo. Saggio su Ludwig Wittgenstein. (Mimesis, Milano 2001). Attualmente collabora all’attività didattica e di ricerca presso le cattedre di Filosofia della Storia e Filosofia Teoretica II dell’Università degli Studi di Milano.