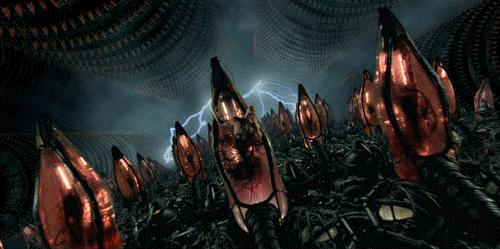“Non chiederai a una mosca com’è fatta la notte, poiché essa vive meno d’un giorno”
(Stendhal)
Sono qui e non ho idea del perché ci sono. Del perché sono. Se cerco di ricordare non trovo niente. Tutto è così come lo vedo. Se c’era un prima non saprei dire, proprio non me lo ricordo. Cosa sia il prima mi sfugge. Prima è quello che precede di un attimo ciò che sto pensando. Nient’altro. La mia memoria non può andare più indietro di questo semplice indietro. Tutto questo è una constatazione. Concetto elementare che dovrebbe essere definito. E, forse, potrebbe esserlo se io fossi in grado di definire cosa significa elementare. Se ci provo mi viene da pensare che tutto ciò che sto pensando è elementare. E mi fermo qui perché sono arrivato in un vicolo cieco senza nemmeno sapere cos’è un vicolo cieco. Neanche cosa sono posso definire.
Quando le cose siano divenute cose non so dire perché non conosco il significato di quando. Anzi non ho nessuna idea di cosa sia il tempo in generale essendo, tutto ciò che percepisco, uguale a se stesso. Essendo privo di un prima, evidentemente sono anche privo di un dopo. Se fossi in un posto qualsiasi, diverso da questo — azzardo un’ipotesi audace — dove per esempio ci fosse qualche cosa che cambia, ogni tanto! Se ci fosse qualche minimo segno di circolarità delle cose, o anche solo un qualche …. mi viene, non so da dove, la parola “clinamen”, una deviazione, una svolta dove girare, allora potrei scegliere qualche punto di riferimento e cominciare a misurare ciò che cambia e ciò che è uguale, allora potrei affrontare questo problema. Ma, ad essere franco, in un mondo come questo non solo non si può affrontare un tale problema: non esiste il concetto stesso di problema. Lo so perfettamente: sto facendo della filosofia e quel ch’è peggio è che non credo di avere strumenti adatti per farla, oltre al fatto empirico che sto cercando di ragionare. Forse il concetto di filosofia equivale, banalmente, al concetto di semplice. O, per meglio dire, equivale a semplicità. Quando si comincia a ragionare da zero.
In fondo, mi verrebbe da dire, se esistesse la filosofia, potrebbe essere utile per cambiare le cose del mondo. Sempre che ci sia qualche cosa da cambiare. Ma lasciatemi sbizzarrire con le mie fantasie. Non so neppure a chi le sto raccontando. Non certo a quelli che mi si pigiano attorno. Infatti qui io non sono solo, a quanto pare, e questa è una circostanza che mi mette di fronte a un baratro vertiginoso. Non perché io avverta qualche minaccia (e quale minaccia potrebbe esserci in questo mondo, dove tutto è immobile, uguale al momento che lo precede e a quello che lo segue). Un mondo dove non c’è interruzione, che funziona così bene, Il fatto è che qui attorno c’è gente che non sa nemmeno che esisto e non saprebbe distinguermi da quello che sta alla mia sinistra. Poi, già i concetti di sinistra e destra sono difficilissimi perfino da concepire in un mondo dove tutto sembra senza confini. E uguale. Se mi giro su me stesso — questo scopro di poterlo fare — il panorama resta identico. Che vi credete? Che la destra sia diversa dalla sinistra? Del resto come potrebbero avere idee di destra e di sinistra questi qui attorno? Sono tutti tremendamente uguali. E quando uno non ha idee, come sembrano tutti costoro, come può essere di destra o di sinistra? E non solo: ti ignorano. Nessuno ti guarda mai negli occhi. Che poi sono come dei frammenti di vetro opaco. Occhi che, a voler essere generosi, li si definirebbe sfuggenti. Ma sfuggenti a che cosa? Faccio paura? O, forse, sono talmente insignificante, che non vale la pena guardarmi, cercare un contatto. Infatti sono occhi spenti, o forse soltanto distratti. Ma da che cosa non si capisce. Da che cosa si può essere distratti se ogni cosa è sempre uguale a se stessa? Più probabile che siano annoiati, o semplicemente stupidi. E non mi è nemmeno del tutto chiaro quali siano gli occhi miei, con i quali li guardo. Ne ho due, scommetto, come quelli degli altri. Ma è solo una scommessa perché non posso guardare i miei occhi. In nessun modo, e dunque non posso contarli. Diciamo che è un postulato, del quale sono costretto a fidarmi.
Potrei avere una risposta chiedendo a questo qui che mi sta vicino quanti sono i miei occhi. Ma potrei farlo solo se avessi un qualche cosa per dirglielo e se lui avesse qualche cosa per ascoltarmi e rispondermi. E entrambe queste caratteristiche sono assenti. Almeno questa è la mia impressione. Dunque finirò per accettare il postulato dei due occhi anche per me. Due vuol dire uno più uno. Se ne avessero tre non saprei neppure come definirli. Mi occorrerebbe saper fare una vera operazione aritmetica, ma non mi risulta di conoscere l’aritmetica. Per cui è una fortuna che loro ne abbiano due, di occhi. E che anch’io ne abbia due. È simmetrico, tranquillizzante. Comunque io vedo, anche se non ho mai visto i miei occhi. Per la verità io, di me, posso vedere solo la mia pancia e quelle due propaggini in basso che toccano terra. Chiamiamoli, per comodità, i miei piedi . Il resto me lo posso soltanto immaginare guardando questi insipidi vicini che, presumo, sono uguali a me. Sono bello o brutto? Neanche questo posso dire, perché — rieccomi con la filosofia — credo che per dire una cosa del genere occorra avere un punto di riferimento. Una qualche forma di paragone. E io non ce l’ho. Ciò che non c’è darebbe senso a ciò che c’è, ma come faccio a valutare ciò che c’è senza sapere ciò che non c’è? Dunque, confesso, sono un tantino confuso.
Dovrei inventarmi un vocabolario di parole, ma anche di concetti. Insomma mi mancano le basi. Tra l’altro ho l’impressione che le basi manchino anche a tutti quelli che mi stanno intorno. Il che non è consolante. Inventerei un proverbio se avessi un’idea di cosa possa essere un proverbio. Comunque eccolo: mal comune, mezzo gaudio. Oppure: bene comune, mezza infelicità. Mi pare che rendano bene l’idea. Anche sull’idea di “io” ci sarebbe da riflettere. Chi mi dice che io sono io? Nessuno. Quello che vedo è un mare di oggetti che si muovono. Diciamo che sono esseri viventi, così, forse, ci capiamo. Tutti uguali. Io anche mi muovo, esattamente come loro, in uno spazio angusto che mi contiene tutto. Un centimetro più in là c’è un altro essere, distinto da me, ma uguale a tutti gli altri “me”. Non chiedetemi cosa vuol dire centimetro. È una parola che ho inventato in questo momento, per far capire che lo spazio è poco. Se lo spazio fosse tanto potrei usare la parola chilometro, così, tanto per dire. Sto inventando un vocabolario senza sapere ancora cos’è un vocabolario. Anche la parola spazio l’ho inventata in questo istante, per indicare dove ho poggiate le mie estremità.
Dunque, riprendendo il ragionamento, cos’è l’”io”? Sono io un io? Sono un individuo? È possibile. Potrei dedurlo dalla circostanza che ho dei pensieri. Sto pensando, questo è certo, anche se l’idea di pensiero è molto difficile da mettere a fuoco. Concludere che: penso, dunque sono, mi sembra azzardato. Che vuol dire? Questi, qui attorno, magari, pensano tutti di pensare. Ma, per questo, possono dire di esistere? Con quegli occhi un po’ così, senza luce, senza barlumi di interesse? Come si fa a esistere se non ci si pone qualche domanda? Se qualcuno affermasse risolutamente che penso, quindi sono, commetterebbe un errore. Pensare non è sufficiente, se non implica una domanda. Pensare senza domande non significa essere: al più significa molta presunzione. Infatti pensare senza porsi domande significa fare una serie di affermazioni. E basta. Ve lo immaginereste un mondo di coglioni presuntuosi che pronunciano solo affermazioni? Voi direte, ma che diavolo di ragionamenti fa costui, senza sapere né cos’è un ragionamento nè cos’è il diavolo? Infatti, è vero, io non so né l’una cosa né l’altra. Banalmente invento. Dunque sarebbe più giusto dire “invento, quindi sono”. Sempre che io possa spiegare, innanzitutto a me stesso, cosa vuol dire inventare. Magari da qualche parte, qua dentro, c’è qualcun altro che è arrivato a queste conclusioni. Ma come si fa a saperlo, visto che questi qui non comunicano niente e, per giunta, io stesso non sono in grado di comunicare con loro? Forse la conclusione più giusta potrebbe essere: comunico, quindi sono.
Dunque, poichè non comunico, allora non sono. Infatti si potrebbe immaginare l’esistenza di un mondo in cui tutti pensano di esistere in quanto comunicano qualche cosa — non importa cosa — agli altri. Ma tutto diventa così complicato che mi sembra di affogare nei pensieri. Per esempio ve ne dico uno, che mi è balenato da qualche parte. E se qualcosa di esterno a tutti noi, a me e a questi sgorbi che presumo mi somiglino, arrivasse e ci consentisse di comunicare tra di noi? Che so, magari un cervello comune, una nuvola, un agglomerato, uno spazio dove ciascuno possa dire quello che pensa e, addirittura, lasciare una traccia indelebile di quello che pensa, allora che succederebbe? Temo che sarebbe una tale cacofonia da fare impazzire anche il più potente dei cervelli. Lasciamo stare la cacofonia, che non so cosa sia. Diciamo, più semplicemente, che ci vorrebbe un regolatore dei pensieri. Una specie di semaforo (ma come mi vengono in mente queste parole?) per regolare i pensieri di tutti. Per stabilire, che so?, una precedenza. Del tipo: il pensiero A è più importante del pensiero B e, quindi, ha la precedenza. Oppure: il pensiero C è più bello del pensiero D. Ma temo che tutti vorrebbero esprimersi contemporanesmente.
Ve l’immaginate una situazione in cui gli scemi hanno la precedenza sugli intelligenti? Sempre che, naturalmente, qualcuno spieghi, agli uni e agli altri, cosa significa essere intelligenti e cosa significa essere scemi. Cosa che vorrei sapere anch’io. Forse sarà bene tornare alle cose più semplici. Ripartiamo dalla banalità. Niente male, direi. Dunque prendiamo per buono il: penso, dunque sono. Ma dopo, come si procede? E dove si va? Questo già non lo saprei dire. E, dalla faccia ebete di quelli che mi stanno attorno, dedurrei che non stanno pensando proprio a niente. Quindi io sono diverso da loro, anche se non ne ho la prova. Magari anche loro pensano, come me, e lo fanno nel chiuso della loro individualità, senza trasmettere niente all’esterno. Infatti neanche io trasmetto niente a loro. Il ragionamento si chiude qui. Dovrei parlare con questo individuo sulla mia destra, che è girato dall’altra parte. Ma, come ho già detto prima (quando non me lo ricordo) non saprei come chiederglielo. In più costui proprio non si volta mai, piegato com’è sui suoi tubicini. E poi non ho una lingua per parlare né un linguaggio.
Sebbene, come vi dirò tra poco, una bocca ce l’ho. Evidentemente non siamo fatti per comunicare tra di noi. Un vero peccato. Tanta, ipotetica, produzione intellettuale sprecata per mancanza di comunicazione. Resta il fatto che siamo qui. Ma, a tratti, mi viene il sospetto che io e tutti quelli che vedo siano parte di un organismo più vasto, che comprende tutti, mentre lascia loro l’impressione di essere individui singoli. Difficile dire. A me piace di più pensare di essere singolo. Ma è questione di gusti. Se decidessi infine di darmi alla filosofia, userei il termine relativismo per definire questo sentimento. Ma poi non saprei spiegare cosa significhi questo pensiero, quindi non lo userò più. Ciò detto, posso guardare le mie estremità, che poggiano a terra e che sono anch’esse identiche a quelle dei miei vicini. Sono sempre identiche a se stesse anche le estremità. Ma le dimensioni di tutti noi ho idea che crescano. Per lo meno ho l’impressione di ricordare che tutti quelli che mi stanno attorno, qualche tempo fa erano più piccoli. Adesso mi paiono più grandi, se non ricordo male.
Deduco che anch’io devo essere diventato più grande. È un’ipotesi suggestiva su cui varrebbe la pena di riflettere. Perché, se fosse vera, allora vorrebbe dire che in questo mondo c’è qualche cosa che cambia. In una sola direzione: dal più piccolo al più grande. Ma della validità di questa legge non si può essere certi. Quello che vedo io cresce, ma che succede un po’ più in là? Chi mi dice che più in là non valga la legge opposta, cioè dal più grande al più piccolo? Insomma si vive nell’incertezza su un sacco di questioni, sebbene questo mondo sembri essere stato concepito per realizzare un ordine assoluto, quindi la certezza totale. L’Ordine è la legge. E la legge dell’Ordine produce incertezza.
C’è qualche cosa che non quadra. No, non è vero. Se c’è un posto tranquillo, sicuro, costante, quieto, è questo. Solo quelli come me (sempre che ce ne siano altri) che si occupano di filosofia, provano il senso dell’incertezza. Deriva dalla curiosità. Se le domande che costoro si pongono li mettono nell’incertezza, è tutta colpa loro. A me piace così. Ah! Dimenticavo di rilevare che siamo in tanti, tantissimi. Non ho idea di come dirlo, ma, se alzo un po’ gli occhi, non vedo che gli stessi corpi, tutti uguali, a perdita d’occhio. E così è sempre stato, a mia memoria. Così, dunque, sempre sarà. Vorrei perfino aggiungere, di nuovo, accidenti alla filosofia, che non sono proprio sicuro che gli altri siano altra cosa rispetto a me. Sono così vicini, tutti così uguali, tutti dello stesso colore, tutti assolutamente presi dai loro affari al punto che non riesco nemmeno a incontrare i loro occhi vuoti, da farmi pensare che io sono loro. Certo io sono come loro. Infatti mi trovo qui, a fare, o a non fare, quello che loro fanno, o non fanno. Vai a capire.
Mi verrebbe da dire che c’è una uguaglianza assoluta. Esterna, quella che si vede. Ma potrebbe anche essere interna. Come dire che quello che penso io lo stanno pensando tutti, oppure l’hanno già pensato, o lo penseranno. Ecco, se sapessi scrivere, mi verrebbe da scrivere (cioè da mettere in qualche posto, in una qualche forma, dove poter ritrovare intatto quello che ho compilato), una ipotesi, un racconto. Per esempio l’idea che tutto quello che uno o una, o un altro che non è uguale né all’uno né all’una (ma questo è un discorso così complicato che mi viene male alla testa a pensarci) abbia pensato o possa pensare, sia già stato pensato da qualche parte, in qualche mondo. E che dunque i miei pensieri siano nient’altro che una ripetizione. Cioè che non ci sia niente da inventare perché è già stato inventato. Mi farebbe tristezza, il pensarlo, senonché non saprei dire con precisione cosa sia la tristezza in un mondo senza gioia. Peggio ancora in un mondo dove non si sa cosa sia la tristezza a la gioia, visto che non c’è niente che possa mutare l’immutabile. E la sola idea di mutamento sarebbe la condizione per provare o l’una o l’altra, anzi l’una e l’altra. Ma – lo capirebbe anche il mio stupido vicino davanti — questo non ha nulla a che fare con questo mondo atarassico. Adesso vai a spiegare da dove viene una parola come questa.
Da dove vengono le parole? Ecco un interessante campo di ricerca. Vuoi vedere che anche le parole sono già state tutte pensate? Non solo. Potrebbero essere pensate (non so come potrei pronunciarle, ma a pensarle ci arrivo) in un ordine e in una successione di frequenze perfettamente definita. Starebbe in sintonia con un mondo dove non succede niente che non sia già accaduto. Perché non pensarlo? Anche questo pensiero, infatti potrebbe essere antico e immobile come tutto il resto. Non ci sarebbero scoperte. Non ci sarebbero intelligentoni che inventano qualche cosa e ai quali qualcuno di questi idioti che mi circondano potrebbe pensare di dare un premio. E magari scopriremmo che la parola magari, come la parola idiota, ricorre nei pensieri di ciascuno di questi idioti con una certa, inevitabile frequenza. Sempre che pensino. Anche questo sarebbe in perfetta sintonia con il mondo di idioti con cui non riesco a comunicare.
Ma questo mi apre un problema: io, in una tale ipotesi, sarei un’eccezione. Cioè sarei il disordine. Sarei inspiegabile, insostenibile. Forse tutto deriva dalla mia mostruosa anomalia. Della quale mi sento in qualche modo colpevole. Sto turbando l’universo. Seguendo l’ordine immutabile delle cose che qui vedo, dovrei essere eliminato al più presto. Ma che significa al più presto e che significa l’idea che un ordine immutabile abbia bisogno di fare presto per fare qualche cosa? A proposito, direi che sarebbe utile trovargli un nome. Diciamo Provvidenza, così ci ciapiamo. O, meglio, così mi capisco io stesso visto che non saprei con chi confrontare quello che penso. Poiché sono un inguaribile ottimista, penso anche che potrebbe esserci una qualche possibilità di mettere in comunicazione istananea tutti questi idioti. Pensa un po’, una specie di cervello collettivo, al quale tutti possano attingere. Così l’intelligenza di qualcuno, per esempio la mia, potrebbe compensare l’idiozia di un altro. E così via. Bene o male qualche cosa di buono potrebbe venirne fuori, ma — a pensarci bene — potrebbe venire fuori anche qualche cosa di cattivo. Per esempio se uno di questi idioti si trovasse, per un qualche motivo ignoto, in condizione di trasmettere la sua idiozia a molti altri. In tal caso costui squilibrerebbe il sistema e assumerebbe un potere inammissibile in un mondo ben ordinato. E, a quel punto, la Provvidenza avrebbe il suo bel da fare a riportare l’ordine. Meglio non provarci nemmeno.
Certo che è un mondo strapieno di gente. Letteralmente uno accanto all’altro. No, non volevo dire uno sopra l’altro. Questo è vietato, ed è anche impossibile. Che ci farei io sopra un altro, o un’altra, o uno che non è né un altro né un’altra? Tanto peggio se io fossi sotto. Ma non c’è nessuna comunicazione tra me e gli altri, e — a quanto vedo nelle mie immediate vicinanze — tra ogni altro e tutti gli altri. Nel mio modesto vocabolario non dovrebbe esserci la parola egoismo. Infatti non c’è. Ma, se ci fosse, direi che è un mondo di egoisti, dove io sarei un’eccezione assoluta. Per il semplice fatto che sono curioso, e la curiosità è una forma di altruismo. Ma neanche questo è dimostrabile. Magari a qualche saltello da qui ce n’è un altro che pensa le stesse cose che penso io. Il problema è che non c’è lo spazio per muoversi.
E poi ci sono i tubicini qui vicino, che non sarei sicuro di ritrovare, nel caso mi si presentasse uno spiraglio per spostarmi. E una cosa che sono certo di avere capito è che questi tubicini sono essenziali, fondamentali. Sono la Provvidenza imperscrutabile. La temperatura è, direi, buona. Chi ha pensato a questo mondo aveva idee tranquille: niente sbalzi, tutto fila liscio. Starei per dire da mattino a sera, se ci fosse un mattino e una sera. Che non c’è. E non saprei neppure da dove mi è venuta fuori questa idea: di una qualche variazione ciclica. Qualcosa di veramente orribile. Forse mi è stata ispirata dal fatto che il cibo arriva, attraverso questi tubicini, a singhiozzo. È però una intermittenza certa, che non viene mai smentita. Non è, per così dire, un evento ciclico (ma dove mi vengono queste parole?). Comunque questa benedetta intermittenza non è stata mai smentita fino ad ora, salvo un caso così eccezionale da produrre in me un panico irrefrenabile. In quel caso il panico fu generale, come è generale tutto ciò che accade in questo mondo. Anche il panico, dunque, fu generale, ma si spense quasi subito. Ecco, si potrebbe dire che qui tutto è davvero generale, valido per tutti. È davvero piacevole sentire che siamo tutti sulla stessa barca. Cosa sia una barca non saprei, ma mi è venuta questa espressione di solidarietà.
Strano anche perché non so cosa significhi solidarietà. E tutti quelli che mi stanno attorno non hanno nessuna ideaa di solidarietà. Infatti mangiano subito tutto quello che arriva dal tubicino che sta nel loro minuscolo territorio. Anzi mangiano e bevono, perché c’è anche un altro condotto dal quale non esce cibo solido, ma liquido. Lo chiamerò acqua. Direi che sia il cibo che l’acqua non sono male. Mi piacciono, anche se l’idea del piacere è strana. Uno potrebbe dire che una cosa gli piace se avesse una possibilità di scegliere un’altra cosa, che poi gli piace meno, o di più. Ma questa cosa qui, in questo mondo in cui mi trovo, non esiste proprio. Dai tubicini viene fuori la stessa cosa. Sempre, a intermittenza fissa. Appunto la Provvidenza. Da quello che vedo sta bene così a tutti. È la natura di questo mondo che è fatta così. Tutto è in regola. L’unica cosa che davvero mi colpisce è che, a quanto pare, anch’io sto diventando più grosso. Ma siccome non posso misurarmi, non mi resta che guardare gli altri e concludere che così vanno le cose del mondo. Si cresce di dimensione, ma restando uguali. Ecco, non ho mai avuto fame. Nessuno sa cosa vuol dire fame. Nessuno qui, ha mai avuto fame, presumo, salvo quella eccezione di cui vi parlerò. Quello che arriva dai tubicini è esattamente ciò che serve. Starei per dire che i due tubicini che ci nutrono fanno parte integrante della natura. Non appena il tubicino segnala un fruscìo, scopri che hai fame. E mangi e bevi. Quando smette il fruscìo non hai più fame. Qualcosa, o qualcuno, ha deciso le quantità. Sembra che la Provvidenza abbia calcolato perfettamente gli stimoli di ognuno. L’unica differenza, molto visibile per la verità, è quando dal buco che abbiamo in mezzo alle due gambe, escono delle cose che non saprei ben definire. Escono per conto loro. È una specie di liberazione, fa piacere. Non è come mangiare e bere, dove il tuo libero arbitrio, si fa per dire, si esercita pienamente. Insomma devi aprire un orifizio, introdurre della roba. Implica una scelta. Elementare quanto si vuole, ma sempre una scelta. Teoricamente, solo, perché tutti mangiano sempre, e bevono quello che arriva. Ma teoricamente io potrei non mangiare tutto, o non bere, tutto ciò che la Provvidenza mi manda. Invece qui la cacca — la chiamo così, per capirci meglio — che io faccio, e che fanno tutti quelli che mi stanno attorno, esce a prescindere dalla mia decisione. Esce quando decide l’orifizio di sotto. E ho notato che non tutti fanno la cacca nello stesso momento e con la stessa intensità. Qui, in effetti, c’è qualche discontinuità, qualche casualità. Per fortuna la cacca sparisce da sola penentrando in certi orifizi che stanno sotto i nostri piedi. Si vanifica in silenzio. La Provvidenza provvede, appunto, a che non si accumuli sotto i nostri piedi. Peccato perché salendovi sopra potrei vedere più in là. Ma non importa perchè sono certo che tutti farebbero la stessa cosa e non avrei nessuna informazione aggiuntiva circa il mio orizzonte.
Non ho dubbi che questo mondo sia il migliore dei mondi possibili. e credo che sia anche infinito. Infatti non se ne vede la fine. Anche qui il termine migliore implica un confronto. Ma poichè non c’è confronto possibile, non resta che la presa d’atto. Siccome non c’è alternativa perché porsi dei problemi? Se si creassero le condizioni per poter trasmettere a qualcuno queste mie modestissime riflessioni, mi piacerebbe scrivere un racconto (ma che significhino la parola scrivere e la parola racconto non saprei precisare). Posso solo pensare che qualche entità superiore me lo abbia in qualche modo insufflato, il che vorrebbe anche significare che io ho un qualche contatto con essa, del tutto inspiegabile. Idea che solo un inguaribile ottimista può coltivare. Essere in contatto con una entità superiore fa sentire l’importanza di esistere. Ma come si possa essere ottimisti nel migliore dei mondi possibili è cosa impossibile.
Mentre ci penso mi viene in mente che un ottimista sarebbe un personaggio ridicolo. Uno scemo. Simile a quello che sto guardando sulla mia sinistra. Un vero cretino, senza finestre, direi. Chiamiamolo una “monade”, per capirci. Per quanto concerne l’idea di “infinito”, anch’essa è strana. Anch’essa presuppone l’esistenza dell’idea di “finito”. Per venirne a capo ho provato un’altra volta ad alzarmi sulla punta delle mie estremità (confesso di averlo fatto molte volte), per vedere oltre la cerchia dei miei vicini. Quello che ho visto è stato un mare di teste, tutte uguali, tutte ondeggianti allo stesso modo, a perdita d’occhio. In silenzio. Qualcuno, però, se non ho visto male, faceva lo stesso mio gesto. Ma, essendo lontano, non si poteva leggere nei suoi occhi un barlume di intelligenza. Poteva essere una qualche esuberanza casuale, come la mia.
Vedo perché il mondo è illuminato: da una luce tenue e anch’essa costante, né forte, né debole. Quieta. Il rumore, l’unico che si sente, è quello delle mandibole, che lavorano in continuazione, senza soste, accompagnato dal fruscio del liquido che scende dai tubicini e dal leggerissimo rumore dei sorsi e delle quasi silenziose evacuazioni. Nessuno, qui attorno, esagera nel fare rumori. Anche quando evacuiamo non si sente quasi nulla. L’odore dell’ambiente non è esaltante. Così l’ho sentito la prima volta e così lo avverto adesso.
Ogni tanto mi piacerebbe sgranchirmi le gambe, come si suol dire (anche se non saprei spiegare cosa voglia dire questa espressione). Per esempio andare un po’ più in là, farmi largo tra la calca, andare a verificare se ogni quadratino, come quello in cui mi trovo, è uguale all’altro. Nulla, infatti, mi dice che troverei chissà quale novità. Ma vorrei sapere cosa c’è in quella zona un pochino più scura, che si vede all’orizzonte, con fatica. Come se la sorgente di luce che inonda il mondo, laggiù, proprio laggiù, si attenuasse un tantino. Ma forse è un’impressione momentanea. Alzarmi sulla punta dei piedi è molto faticoso e dura solo qualche secondo. Solo salendo sulle spalle del mio vicino potrei davvero guardare. Ma non oso pensare a come reagirebbe. Intuisco che sia una specie di peccato mortale (che diavolo sia un peccato mortale, non saprei, anche perché non c’è segno di morte, come non c’è segno di vita). In ogni caso sarebbe uno sgarbo grave, una rottura della sua personalità. Io non posso sapere se ha una personalità, cos’abbia in testa, se sappia che io esisto. Ma lo scoprirebbe suo malgrado come un mostruoso atto di violenza su di lui, su di lei, su di esso. Anche questa riflessione mi mette a disagio.
Da dove vengo? C’è un dove? E c’è un quando che definisce perché e come sono arrivato qui, in questo mondo? Tenderei a escludere l’una cosa e l’altra. Molto più semplice immaginare che siamo eterni e siamo qui da sempre. Certo resta il problema dei tubicini. Chi li ha messi qui? Ma la domanda potrebbe anche essere questa: chi mi ha messo qui? E perché funzionano sempre nello stesso modo? Ci dev’essere una sorgente, qualcuno che ci ha pensato. O forse no.
Ma, diciamocelo francamente, tutto questo ordine suggerisce l’idea che una mente deve averlo prodotto. Ma farsi venire un’ idea è un conto, trasformarla in realtà è altra faccenda. Supponiamo, per assurdo — di nuovo torno a fare il filosofo senza avere mai studiato filosofia, anzi senza nemmeno sapere cos’è la filosofia, o cos’è il sapere — che qualcuno abbia pensato a me. Ma farmi dev’essere stato difficile. Con i tubicini e tutto il resto. Io, per esempio, potrei pensare di costruire un me stesso che vola. Ma come si faccia a volare non avrei idea. Cosa ci vuole per volare sopra le teste di questi idioti? Magari un vento così forte da sollevarmi in aria. La questione è restarci, visto che di vento non ce n’è, e neppure saprei descriverlo.
La questione è irrisolvibile. Direi che mi manca il concetto di tecnologia. Ma, comunque, stabilendo come ipotesi che una mente abbia pensato e poi realizzato quello che io vedo attorno a me, resta il fatto che non mi sembra granché. A ben pensarci tutto sembra molto monotono. Questo qualcuno potrebbe essere stato un monomanicaco, uno psicopatico amante dell’ordine e della quiete. E chi potrebbe essere stato? Io qui attorno vedo solo teste spelacchiate. Sarà uno di loro? Perché no? Potrebbe benissimo essrsi mimetizzato, assumendo le sembianze di tutti. Perché lo avrebbe fatto? Magari — azzardo — per verificare se tutto funzione a dovere, come aveva previsto. Io, sicuramente, non sono responsabile, ma immagino che una tale mente, se c’è, debba avere le sembianze di uno di noi. Una testa spelacchiata piena di idee e di fantasie, ma che ha deciso di disegnare un mondo ordinato. Mi pare una contraddizione in termini, ma non lo si può escludere.
Mi giro un pochino e guardo il mio vicino a sud-ovest. Cosa sia il sud-ovest non ho la più pallida idea. Mi serve per identificare la sua posizione, un po’ a destra del mio piede sinistro. Così almeno sono riuscito a definire me stesso. Che, lo confermo, è un essere con due piedi e due occhi, esattamente come gli altri. Gli altri che vedo, ma non potrei affermare che non ci siano individui che hanno, per esempio tre occhi e due piedi, o tre piedi e due occhi, o — perché no? — quattro piedi e tre occhi. Comunque questo individuo a sud-ovest non reagisce a nessun mio ammiccamento. Idiota come tutti quelli che riesco a vedere. Forse ha paura, forse finge. Glielo chiederei se avessi un organo per trasformare i miei pensieri in parole. Se mi concentro viene fuori un gorgoglìo che sento soltanto io. Se i vicini lo sentano non so. Forse fanno finta di non sentire. Dovrei gridare per misurare la loro reazione, ma non so gridare.
Interrompo un attimo perché sento il fruscio del cibo in arrivo e il fluire dell’acqua. E, quando ho fame e sete, non riesco proprio a ragionare. Mi prende come un vortice si sensualità. Di beatitudine. La Provvidenza innanzitutto. Poi l’evacuazione quasi collettiva. Adesso, una volta saziato, nel breve periodo di tempo che mi separa dalla prossima mangiata e bevuta, posso riprendere a ragionare, a soddisfare le mie curiosità solitarie. A stomaco vuoto è più difficile filosofare.
Se non posso guardare ai confini del mondo, sempre che esistano, posso sempre guardare in alto. Lo faccio con fatica, perché il mio collo sembra non essere stato pensato per guardare verso l’alto da quella mente di cui pensavo poco fa. Anzi l’unica direzione verso cui punta la testa è verso il basso, cioè verso i tubicini. Questo è dunque l’ordine della Provvidenza: guardare verso il basso. Forse è un peccato guardare verso l’alto e ciò spiega perché siamo fatti in questo modo. Ma la curiosità è anch’essa figlia della Provvidenza, mi dico forzando un po’ la mano. Che sarebbe un bel movimento se sapessi cos’è una mano.
E, forzando anche il mio collo, guardo quello che mi viene spontaneo chiamare cielo. Affascinante e incomprensibile come tutto il resto. Sembra un lenzuolo di luce uniforme. Ma, se uno cerca di fissare lo sguardo — che male al collo! — per qualche attimo, ecco la sorpresa: sono tantissime palline quasi rotonde, tutte ugulmente luminose. Ecco, questo mondo è sormontato da un cielo tutto ugualmente luminoso, ma è un soffitto di palline, tutte uguali. Una monotonia affascinante ma anche un po’ noiosa. Sembra piatto. E, naturalmente infinito. Anche la sua assoluta uniformità indica la perfezione di chi lo ha concepito. Uniformità? Se devo essere sincero è una uniformità con qualche eccezione. Qua e là nel lenzuolo luminoso si vede qualche puntino nero. Qualche pallina sembra spenta. Ma è l’eccezione che conferma la regola. Tutto è regola. Se avessi tempo mi piacerebbe studiare se esiste qualche regolarità nell’apparizione di questi puntini neri. Potrei vedere se diventano chiari e altri puntini neri sostituiscono quelli che diventano chiari. Ma mi viene male al collo e quindi non lo faccio.
Ci fu un solo momento in cui questa continuità venne interrotta da un evento discontinuo. Il cielo si spense d’un tratto. Tutto, all’improvviso. Qualcosa accadde, un segno di disordine che produsse il buio più nero. E anche I tubicini smisero di funzionare. La cosa, per quanto straordinaria, non suscitò alcuna reazione. Per lo meno io non avvertii fremiti di terrore nei miei vicini. Per essere sincero fino in fondo io ebbi paura, mentre gli altri, attorno, non mossero un pelo. Impassibili. Un a-plomb inglese praticamente universale.
La parola “inglese” mi è venuta così spontanea che ho pensato di averla vista, o sentita da qualche parte. Ma siccome non sono mai stato da nessuna parte, mi è venuta l’idea che io ho già vissuto da qualche altra parte. O che vivo simultaneamente da due parti diverse, o da enne parti diverse. Così si spiegherebbe anche il fatto che penso in una lingua che non conosco affatto. Questa è un’ipotesi davvero audace. Ipotizzarla mi fa venire un brivido di entusiasmo.
In ogni caso il buio fu totale e io avvertii, insieme alla mia personale paura, la grandezza incommensurabile di quanto stava accadendo. Capivo che si stava verificando un evento storico, che gl’idioti attorno a me non erano in condizione di percepire. Ecco perchè se ne stavano fermi. Ma li scusai. Se ciascuno restava fermo al suo posto era perchè non avrebbe saputo dove andare.
Neanche io sapevo dove andare. Io come gli altri. Li sentivo muoversi appena leggermente, urtarmi , oscillare da tutte le parti. O ero io che urtavo i miei vicini. Ma in quegli attimi — quanto durarono non saprei dire, non ho mica un orologio! (termine che uso per indicare il tempo che passa) — furono come una parentesi paurosa, misteriosa.
Non avevo mai visto il buio. Che è una cosa che non si vede, ma si sente. Ecco, fu un momento in cui percepii, acuta, una sensazione comunitaria. Ma come si fa a sentirsi fratelli di qualcuno se non c’è nessuna comunità? Fu, strano a dirsi, una bella sensazione. Proprio il suo carattere comunitario mi diede la speranza di poter comunicare.
Ma poi il cielo tornò a brillare fiocamente, come prima. Anche i tubicini, che si erano azzittiti mentre la luce si spegneva nel buio, ripresero a frusciare e, con loro, la certezza che la Provvidenza continuava a funzionare. Pensate, non era mai accaduto. Ci sarebbe stato da parlarne per chissà quanto tempo. Si era realizzata la storia. L’unico evento della nostra vita. Ma, al ritorno della luce, che era anche una specie di resurrezione, di epifania, gli occhi dei vicini restarono spenti, proprio come lo erano prima. Si erano già dimenticati, o fingevano, dell’eccezionalità dell’evento. Non era colpa loro. Quando sei abituato alla continuità anche la discontinuità affoga nel mare della routine.
Bella parola! Se questa massa informe di individui si organizzasse in qualche modo, ci potrebbero 0 essere perfino delle comunità che parlano (no, parlare non potrebbero, perchè non hanno l’organo per farlo) anzi pensano in lingue diverse. Ecco, supponiamo che in una lingua qualunque, diversa da quella con cui ragiono io, la parola abitudine si possa tradurre con routine. E sarebbe necessario, quando due idioti di diverse comunità s’incontrano per caso, dotarli di un interprete, capace di spiegare a entrambi che abitudine e routine sono la stessa cosa. Sarebbe divertente.
Dimenticavo di menzionare un fatto che mi colpì moltissimo. Lassù, in cielo, c’erano anche strani individui. Immobili del tutto, come il cielo in cui abitavano. Ma con un occhio solo. Un occhio fisso, scuro, scurissimo. Erano molto radi, molto più radi delle palline luminose del cielo. E anche loro guardavano sempre e soltanto verso il basso. Non solo, ma non si guardavano mai reciprocamente. Del tutto asociali, mi parve. Capire, da lontano, a cosa pensassero era però del tutto impossibile. Troppo remoti per poter cogliere in quell’unico occhio qualche elemento di solidarietà. Mi venne in mente che sarebbe stato bello conoscerli. E sospettai che qualche volta scendessero anche loro. Se non altro per venire a prendere la loro razione di cibo e di acqua dai nostri tubicini, visto che accanto a loro non si vedevano tubicini. E, dopo averli osservati a lungo, ne conclusi che non defecavano neppure. Strani tipi.
Ma fui finalmente appagato dal miracolo che, a un certo punto, ebbi l’occasione di osservare. Dico miracolo per spiegare la sua assoluta unicità. Non ne vidi altri, ma quello fu davvero un miracolo, grande immenso, poetico. Arrivarono gli angeli. Non so perché li chiamo così. Forse perché la parola mi ricorda qualche cosa di etereo, di puro, di immacolato. Comunque, chiamiamoli come ci viene bene, angeli o diavoli, o carote: tutte parole per me nuove, da riempire del significato che troviamo più conveniente per le nostre esigenze. Non so come esprimere meglio questa idea.
Diciamo che procedo per associazioni mentali. Se fossi un grande medico, mi diletterei a studiare il cervello della gente mediante le associazioni mentali. Chissà cose ne verrebbe fuori. Grandi scoperte, grandi intuizioni. Ma io sono un abitante del migliore dei mondi possibili, dove le scoperte, e i dubbi, non possono nemmeno essere concepiti. Dunque scelgo le parole per l’associazione spontanea, che io non controllo. Che ci posso fare se quelle figure bianche mi fanno venire in mente la parola angeli?
Insomma la finisco qui per non tediare me stesso, unico soggetto in grado di concepire quello che penso. Arrivarono, anzi apparvero, si materializzarono ai miei occhi. Se uno mi chiedesse da dove vennero non saprei dirglielo. Avrei voluto chiederlo all’idiota alla mia destra, ma, per essere gentili nei suoi confronti, sembrava che non si fosse accorto di niente, come al solito. Descriverli non è difficile, tanto mi rimasero impressi negli occhi. Erano lunghissimi, nel senso che direi verticale, cioè verso il cielo. Tutti bianchi. Svolazzavano su di noi chinandosi talvolta, quando proiettavano fuori di sé alcune protuberanze, bianche anch’esse salvo sulle punte, dove c’era un colore più scuro, simile alle nostre evacuazioni, ma, a differenza di quelle, erano solide. Quelle protuberanze avevano delle singolari terminazioni multiple e mobili. Graziose da vedere. Non saprei dire quante fossero quelle terminazioni degli angeli. Non ho dimestichezza con l’aritmetica. Ma sono arrivato al numero tre, che è quello che supera di uno i due occhi. Dunque le punte erano sicuramente più di tre. Ma concentrandomi vidi che erano anche meno del doppio di tre. Chiamiamo cinque quel numero, o magari quattro. Erano, alcune di quelle protuberanze e terminali, mobili, in grado di afferrare le cose. Potevano perfino spostare delicatamente i tubicini senza romperli. Ma non era quella la loro occupazione principale. Direi che ne avevano una molto più importante, spirituale direi, se avessi un’idea di cosa sia lo spirito: erano venuti, pensai, per prelevare gli eletti.
Chiamo così quelli, tra di noi, che, per qualche ragione a me sconosciuta, erano caduti a terra e non bevevano più né mangiavano. Uno di questi l’avevo intravvisto anch’io, appena fuori dalla cerchia dei miei più stretti vicini. Si intravvedeva, tra le loro estremità, che qualcuno era caduto sui tubicini del mio vicino, il quale era costretto a spostarlo ogni volta che voleva soddisfare i dettati della Provvidenza. Sdraiato a terra, immobile, ieratico. Forse aveva avuto una rivelazione. Una delle protuberanze si chinò fino a lui, lo sollevò verso il cielo e lo fece sparire nella pieghe di quella grande tunica bianca. Non prima di avere portato l’eletto nei pressi della sommità dell’angelo, dove si poteva vedere, sullo sfondo del cielo luminoso, una unica e grande protuberanza che, da lontano mostrava di avere parecchi buchi, o cavità. Una delle quali, molto più grande delle altre, emetteva a tratti dei suoni musicali, o qualcosa del genere. Erano più di uno e si muovevano veloci, fluttuanti, silenziosi, austeri.
Ciascuno raccolse degli eletti, che erano parecchi e, quando ebbero terminato il loro servizio, sparirono com’erano arrivati. Cercai di indovinare perché gli eletti cadevano al suolo in modo così disordinato. Ma pensai che l’estasi può produrre eventi sorprendenti, specie nell’imminenza dell’arrivo degli angeli. Che forse gli eletti avevano presentito in anticipo e, cadendo, intendevano segnalare la loro presenza, appunto per essere raccolti. Avevo pensato di chiederglielo, ma poi rinunciai. In primo luogo perché non avrei saputo formulare la domanda. In secondo luogo perché sembravano fortemente intontiti.
Pensandoci bene, negli ultimi tempi anch’io sentivo una certa pesantezza, una qualche voglia di riposare. Forse ero vicino anch’io all’estasi, ma gli angeli erano arrivati prima. E poi, nessuno mi aveva avvisato. Certo è che provai invidia per loro, intendo dire per gli eletti. Desiderai fortemente di essere uno dei fortunati che erano stati prelevati. Chissà a quali meraviglie erano destinati, a quali straordinarie sorprese! Salivano in alto, sollevati e leggeri, e io rimanevo inchiodato a terra. Così non fui degnato della minima attenzione. Nessuna delle protuberanze e dei tentacoli multipli si avvicinò a me, sebbene avessi impiegato tutte le mie energie per farmi notare. Purtroppo il fruscio del cibo arrivò proprio in quel momento e pensai che la Provvidenza era più importante anche dei miracoli.
Ma, adesso, ripensandoci, sento che fu un’occasione perduta. Questo ricordo del miracolo mi è venuto in mente proprio in questo momento. Come fosse ieri. Altra sciocchezza che non saprei spiegare, visto che un ieri non è mai esistito, come non esiste un oggi e un domani in un mondo perfetto dove il cambiamento è miracolo. Comunque c’è stata come una bufera improvvisa. Senza angeli e molto rumorosa. Anche un vento è arrivato a turbare la quiete lattiginosa della nostra vita. E suoni stridenti mai percepiti. Ora mi trovo quasi sepolto dai miei vicini idioti e da una massa di individui che mi sta schiacciando in modo che direi doloroso. Il dolore è una cosa del tutto nuova. Una cosa spiacevole.
Mi verrebbe da gridare, appunto per il dolore. Quello che ho visto è una cosa molto dura, luccicante, dentata. L’ho vista avvicinarsi e raccogliere tutti, proprio tutti quelli come me che stavano a terra. Sono finito in un grande sacco. Lo chiamo così perchè ci contiene tutti, molto stretti, a caso. Non siamo più tutti ritti, paralleli, attaccati ai nostri tubicini. Siamo uno sopra all’altro. La mia testa è sotto le estremità di un altro individuo. Che scalcia freneticamente, lo stolto, e mi colpisce negli occhi. Anch’io sto scalciando, senza alcun senso. E tutti intorno, sottosopra, scalciano e si colpiscono reciprocamente. Ci sono rumori attorno che non ho mai sentito, stridii, che si mescolano con i suoni degli individui come me, che mi schiacciano e provano dolore.
E, ecco l’altra cosa nuova: lo esprimono con dei suoni strani che anch’essi non avevo mai sentito. Non vedo niente, solo carne e peli e ansimare indistinto. Non c’è più nessuna luce costante. Non c’è nessuna luce. Una cosa che avevo provato solo con l’arrivo degli angeli. Ma ora non si vede niente e la luce non torna. Solo a tratti filtrano dal mucchio lampi fortissimi, lancinanti, che costringono a chiudere gli occhi. Gli odori sono completamente diversi e ho una grande nostalgia dei miei tubicini. Tutti evacuano disordinatamente. Io come loro. Provo un sentimento di grande inquietudine. Dolore e — come chiamarla? — paura. Forse. Non c’è più nessuna continuità in tutto questo. Sono in una discontinuità.
Ho continuato a ragionarci sopra ed ecco che è arrivata, ma non sono sicuro che mi piaccia. Adesso mi sento proiettato con grande forza fuori da quel sacco e precipi………..
Giulietto Chiesa
Agosto 2018