di Andrea Zhok
Negli anni del dopoguerra la festività del 25 aprile venne investita di un ulteriore ruolo di compattamento del nuovo arco costituzionale che doveva prendere le distanze dalle ampie rimanenze del regime fascista all’interno delle istituzioni (a partire dalla magistratura). In quel periodo e fino a quando quella generazione non si esauriva, dunque fino agli anni ’70 circa, la celebrazione e più in generale la rivendicazione di antifascismo aveva un ruolo politico ben definito: non si trattava semplicemente di una condanna storica, ma di una condanna storica con una funzione politica concreta. E che il fascismo meritasse quella condanna era fuor di dubbio, giacché, nonostante alcuni lasciti positivi (la Riforma Gentile, l’IRI), il suo principale lascito alla fine era stata una devastante sconfitta bellica e la sostanziale subordinazione dell’Italia agli USA (subordinazione che, peraltro, nel dopo guerra penalizzò soprattutto il Partito Comunista).
Già con gli anni ’80 l’anniversario della liberazione dal nazifascismo aveva preso una mera piega autocelebrativa per una classe politica che cominciava a risultare invisa a una parte significativa dei governati: a fronte di una fisiologica dissoluzione sia della realtà che della memoria del fascismo reale, l’antifascismo serviva sempre di più come esibizione retorica che avrebbe dovuto conferire credito morale ad un ceto politico cui tale credito veniva riconosciuto sempre meno.
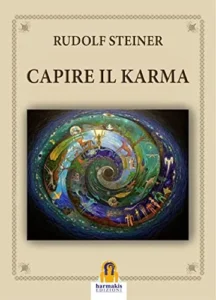
A partire dagli anni ’90, con il crollo dell’URSS, la nascita dell’UE e il trionfo del modello neoliberale, l’antifascismo e le sue celebrazioni assunsero definitivamente un carattere museale. Il termine “fascismo” e “fascista” veniva ormai utilizzato come un generico insulto. Luciano Violante nel suo discorso di insediamento come presidente della Camera dei Deputati, nel 1996, chiese per la prima volta esplicitamente una riconciliazione nazionale tra chi, oramai mezzo secolo prima, si era trovato su fronti avversi (Resistenza partigiana e Repubblica Sociale Italiana).
Da allora sono passati altri tre decenni. Una volta l’anno, in occasione della festività nazionale del 25 aprile, si rinnovella la sceneggiata dell’antifascismo in assenza di fascismo. La Russia si è riconciliata con lo zarismo e con il comunismo, la Cina si è riconciliata con il celeste impero e con la Rivoluzione Culturale, persino gli USA hanno riconciliato i fronti della guerra che ha ucciso più americani nella storia, la guerra civile tra Nord e Sud. Ma se dovessimo prendere sul serio il discorso dell’odierno mainstream nel passato nazionale tra il 1922 e il 1945 non c’è niente da comprendere, solo da abiurare. La parola d’ordine dell’antifascismo serve oramai soltanto a ricompattare le truppe dei liberali di sinistra (così come l’anticomunismo serve a compattare le truppe dei liberali di destra). Nonostante esistano oramai approfondimenti e analisi storiche dettagliate e intelligenti del fenomeno storico del fascismo (tra tutti ricordo la vasta opera di Emilio Gentile), la paroletta “fascismo” (come quella “antifascismo”) viene usata come un guscio vuoto, un riflesso pavloviano, una suggestione emozionale che galleggia sulla più totale ignoranza storica.
Ed è solo così che può accadere che proprio chi più si riempie la bocca di antifascismo:
1) giustifica (o finge di non vedere) una ferrea censura sui mezzi di comunicazione, come fece il fascismo;
2) accetta che carriere vengano fatte e disfatte in base all’accordo o disaccordo ideologico con le verità di regime, come fece il fascismo;
3) accetta che non esistano più organismi capaci di difendere i lavoratori, come avvenne col fascismo;
4) considera normale ed anzi auspicabile che la ricerca scientifica sia asservita agli interessi e scopi dei ceti dirigenti, come accadde durante il fascismo;
e sempre in analogia col ventennio:
5) manipola serenamente e spudoratamente la storia e l’informazione per dar man forte all’ideologia dominante;
6) permette a gruppetti di autonominati guardiani dell’ortodossia di bullizzare i dissenzienti;
7) svuota il diritto di voto limitando le opzioni votabili a varianti di un’unica e sola agenda (There Is No Alternative);
8) impone e incentiva un’ortodossia linguistica ed espressiva, e ghettizza chi non vi si conforma (Politically Correct);
9) consegna all’oblio, emenda forzosamente o distrugge, prodotti culturali (presenti o passati) ritenuti ‘immorali’, ‘diseducativi’, ecc. (Cancel Culture);
10) permette la discriminazione di intellettuali, sportivi e artisti sulla sola base della mancata adesione ad un paradigma ideologico o della nazionalità di appartenenza (qui siamo persino un po’ oltre quanto fece il fascismo).
Ecco, quando una parola viene brandita come un’arma, come un insulto, risparmiandosi un’analisi dei suoi contenuti effettivi, può accadere che quei contenuti ritornino in forma persino peggiorativa, crescendo nascosti dall’ombra gettata da quella parola.
E qui, qualcuno dirà che, dopo tutto, almeno oggi le classi dirigenti del Partito Unico Liberale non ci hanno condotto ad una guerra catastrofica, come fece il Partito Nazionale Fascista.
Eh già, ma dategli tempo.
 Andrea Zhok, nato a Trieste nel 1967, ha studiato presso le Università di Trieste, Milano, Vienna ed Essex. È dottore di ricerca dell’Università di Milano e Master of Philosophy dell’Università di Essex. Oltre a saggi ed articoli apparsi in Italia e all’estero, ha curato scritti di Simmel (Il segreto e la società segreta, 1992) e Scheler (Amore ed odio, 1993). È autore di Intersoggettività e fondamento in Max Scheler (La Nuova Italia, Firenze 1997), Fenomenologia e genealogia della verità (Jaca Book, Milano 1998), Introduzione alla “Filosofia della psicologia di L. Wittgenstein (1946-1951) (Unicopli, Milano 2000) e L’etica del metodo. Saggio su Ludwig Wittgenstein. (Mimesis, Milano 2001). Attualmente collabora all’attività didattica e di ricerca presso le cattedre di Filosofia della Storia e Filosofia Teoretica II dell’Università degli Studi di Milano
Andrea Zhok, nato a Trieste nel 1967, ha studiato presso le Università di Trieste, Milano, Vienna ed Essex. È dottore di ricerca dell’Università di Milano e Master of Philosophy dell’Università di Essex. Oltre a saggi ed articoli apparsi in Italia e all’estero, ha curato scritti di Simmel (Il segreto e la società segreta, 1992) e Scheler (Amore ed odio, 1993). È autore di Intersoggettività e fondamento in Max Scheler (La Nuova Italia, Firenze 1997), Fenomenologia e genealogia della verità (Jaca Book, Milano 1998), Introduzione alla “Filosofia della psicologia di L. Wittgenstein (1946-1951) (Unicopli, Milano 2000) e L’etica del metodo. Saggio su Ludwig Wittgenstein. (Mimesis, Milano 2001). Attualmente collabora all’attività didattica e di ricerca presso le cattedre di Filosofia della Storia e Filosofia Teoretica II dell’Università degli Studi di Milano




